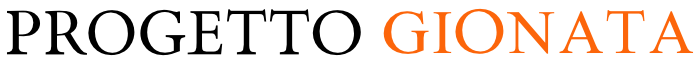Identità maschile e femminile nella riforma
 Intervento della pastora valdese Anne Zell tenuto alla conferenza su ‘La donna nelle tradizioni religiose’, Genova, 12 Febbraio 2004
Intervento della pastora valdese Anne Zell tenuto alla conferenza su ‘La donna nelle tradizioni religiose’, Genova, 12 Febbraio 2004
Vengo dalla Chiesa regionale del Baden, che è unitaria: ciò significa che è una chiesa protestante che ha cercato di riconciliare il ramo protestante e il ramo riformato.
Come saprete il mondo evangelico consta di moltissime denominazioni diverse: Federico il grande ha cercato in Germania di riunire le chiese evangeliche, così le chiese regionali sono diventate chiese unite.
Non dico altro sulla mia persona e nemmeno su cose che potrebbero interessarvi come sul mondo ecumenico a Milano, dove per esempio esiste un Consiglio delle Chiese cristiane e associazioni di dialogo interreligioso.
Oggi vorrei non parlare soltanto io, perché il tema stesso invita ad un confronto: «Uomini e donne nelle chiese riformate» interessa a tutti noi perché veniamo chiamati ad una testimonianza comune di uomini e donne, credenti, nella Chiesa universale.
La domanda di fondo che pongo nel mio intervento è se la Riforma davvero ha cambiato la condizione delle donne nella Chiesa, e qui c’è subito da dire un sì e un no. Sì la Riforma ha creato le condizioni per un cambiamento, ma non ha subito significato un cambiamento; le donne sono rimaste al loro posto: non c’è stato un ministero femminile se non un ministero, se vogliamo chiamarlo così, della moglie del pastore.
E in questo contesto si conoscono personalità anche fortissime: Caterina Bora, moglie di Lutero, e le mogli di altri grandi riformatori. Però non c’era allora un cambiamento dei ruoli: le responsabilità rimanevano precluse alle donne.
Sono due le questioni fondamentali: due nodi sui quali dobbiamo riflettere. Uno è il sacerdozio universale di tutti i credenti, e l’altro è l’insegnamento e la cultura da impartire a tutto il popolo. Questo per permettere a tutti i credenti di leggere la Bibbia e diventare credenti responsabili avendo un contatto immediato con le Scritture e con Dio stesso.
In che modo questo è servito ad un cambiamento della posizione delle donne come credenti, testimoni e chiamate a prendersi delle responsabilità?
Lutero stesso in una sua pubblicazione che si intitola «Come si devono istituire i ministeri nella chiesa» ha scritto che tutti i cristiani sono sacerdoti, tutti i credenti sono sacerdoti, e questo lo ricava soprattutto dalla Lettera agli Ebrei, dalla vocazione di tutti i credenti, nel battesimo, di diventare figli dell’unico Dio.
E perciò dice: l’unico sommo sacerdote, l’unico tramite che rimane tra i credenti e Dio, è Cristo stesso. Al contatto diretto e alla responsabilità diretta davanti a Dio sono chiamati tutti i credenti, e perciò l’unico ordinamento, l’unica consacrazione che Lutero e con lui anche gli altri riformatori riconoscono, è la consacrazione all’interno del battesimo.
Infatti lo stesso Lutero dice che col battesimo non siamo solo riconosciuti figli e figlie di Dio, ma anche sacerdoti, e già in qualche modo chiamati a partecipare alla legge di Dio; cioè il battesimo significa essere già salvati, già partecipi della realtà nuova che Dio crea, qui, in questo mondo. Il sacerdozio universale, questa scoperta, si basa sulla Bibbia come unico fondamento nella Rivelazione da parte di Dio.
E qui potremmo aprire un piccolo excursus perché ho visto che in una delle precedenti relazioni «Gesù e le donne» quando si esaminano i vangeli non si può non notare una differenza del comportamento di Gesù verso le donne rispetto alla tradizione anzi Gesù spezza delle barriere, discute di teologia con delle donne, si rivela come Cristo ad una donna straniera, una samaritana, riconosce ad una donna senza nome, che poi viene chiamata Maria di Magdala che unge Gesù prima della sua passione, riconosce a questa donna che si parlerà di lei dovunque sarà annunciato il Vangelo.
Poi c’è l’esempio di Marta, che esprime una confessione di fede che è tuttora il fondamento delle nostre chiese cristiane: «Tu sei il Cristo, colui che noi aspettiamo». Questi sono solo pochissimi esempi, per non parlare anche della donna cananea alla quale Gesù dice: «La tua fede ti ha salvato».
Perciò già partendo dalla testimonianza delle Scritture, secondo la Riforma il discepolato non era precluso alle donne. Ma intorno a Gesù c’erano uomini e donne, perciò possiamo dedurre dal versetto in cui si dice che lo servivano delle donne, oppure dal seguito delle donne che lo seguiva, che il gruppo intorno a Gesù era una comunità di eguali. Gesù chiamava ad un discepolato di eguali.
Un altro punto importante: le donne interno a Gesù non solo sono attestate come seguaci, ma possiamo osare dire che c’era anche una prima apostola. Se leggiamo attentamente soprattutto i racconti della passione e della resurrezione la prima testimone delle tomba vuota, la prima persona che ha incontrato il Risorto, è stata una donna, perché, mentre i discepoli maschi si davano alla fuga, le donne erano le uniche a guardare da lontano la croce, le uniche che osavano poi andare, all’alba, alla tomba vuota.
Maria di Magdala riceve, come prima persona, l’incarico di annunciare che Gesù è il Vivente e perciò possiamo considerarla la prima apostola, perché essere apostoli vuol dire nient’altro che essere chiamati ad annunciare che Cristo è vivente, l’Evangelo, il Regno di Dio.
Perciò le radici di una vocazione, sia per uomini che per donne, di essere testimoni dello stesso Vangelo, la troviamo nella Bibbia. La Riforma non ha fatto nient’altro che riscoprire queste radici. Per non parlare delle profetesse dell’Antico Testamento.
Il punto di partenza era quindi il sacerdozio universale, un contatto diretto con Dio, vivere una vita coerente davanti a Dio stesso. Il secondo nodo importante era l’istruzione del popolo; e qui cito di nuovo Lutero, visto che comunque provengo dalla Germania e questo è uno dei miei maestri di teologia.
Lutero ha scritto tantissimo e ha scritto lettere a persone che avevano incarichi politici, ai borgomastri, ai consiglieri di tutte le città in Germania, perché istituissero delle scuole: è importante che i ragazzi non imparino soltanto un mestiere, ma che vadano a scuola per imparare a leggere e scrivere. Allo stesso modo una ragazzina può avere un’ora al giorno da dedicare alla scuola e perciò già qui tra le righe si accenna che l’istruzione, saper leggere e scrivere, non deve essere preclusa alle ragazze, ma almeno una minima istruzione deve essere data anche a loro.
Purtroppo nell’epoca della Riforma il ministero della parola era riservato solo agli uomini; infatti le università ancora per molti secoli furono chiuse alla donne. Però c’era la figura interessante e anche molto importante della moglie del pastore evangelico. Sappiamo che Caterina di Bora, che prima di sposare Lutero era in convento, è stata un personaggio molto forte e ha inciso anche sul lavoro di Martin Lutero. E perciò anche le altre donne non avevano un ministero riconosciuto ufficialmente, ma in quanto erano compagne dei pastori nella scuola domenicale.
La formazione dei bambini e delle ragazze spesso era compito delle donne, che nella Riforma non avevano ancora un ruolo pubblico, ma una loro dignità in quanto partecipi al compito di insegnamento della Parola di Dio. Proprio nell’istruzione popolare di base, alla quale avevano diritto anche le ragazze, e nello statuto universale dei credenti ha origine la riappropriazione delle libertà cristiana, che oggi permette alle donne protestanti di essere addirittura predicatrici riconosciute, consacrate, della Parola.
E’ molto curioso che le radici più lontane della libertà delle donne di predicare non si trovano solo nella Riforma, ma già le troviamo nei movimenti eterodossi del Medioevo, in cui le donne predicavano pubblicamente sulle piazze. Purtroppo le tracce di questo ruolo delle donne le troviamo solo negli archivi dell’Inquisizione, nelle liste di «errori» dei valdesi e dei movimenti eterodossi e, qui troviamo che esisteva l’idea che tutti possono predicare, persino le donne; e che i predicatori erano comunità miste, uomini e donne, che non si sposavano ma che condividevano questa testimonianza di predicazione pubblica, la vocazione a cambiare vita, ed è chiaro che questo era uno scandalo. Infatti delle donne che invece di sposarsi e dedicarsi alla vita rinchiusa in casa, giravano con queste comunità molto libere, addirittura predicavano e insegnavano pubblicamente, nel XII secolo poteva solo significare che erano streghe, maghe, pericolose da eliminare.
Allora possiamo chiederci: se Gesù stesso ha abbattuto delle barriere, se Gesù stesso ha creato delle comunità di uomini e donne, di discepoli eguali, se nei primordi della Riforma si parla di sacerdozio universale, come mai le donne hanno dovuto aspettare altri quattro secoli prima di essere considerate sullo stesso livello come credenti, cioè degne di rivestire incarichi pubblici nelle responsabilità?
Il primo punto da considerare è che la Riforma stessa opera in una chiesa ancora socialmente da riformare; tutti i movimenti rivoluzionari hanno luogo soltanto nel Seicento, un secolo dopo la Riforma, e perciò sia Lutero che poi anche Calvino nella sua Istituzione tengono conto di un ruolo della donna, ma sempre come aiutante. Infatti Calvino scrive: «Non a donne o a persone private è stato detto di battezzare e di annunciare l’Evangelo, ma alla Chiesa», e questo significa che anche Calvino sottolinea l’importanza del ministero consacrato.
Lo stesso Karl Barth, nel secolo scorso, purtroppo ancora sottolinea questo fatto riferendosi all’apostolo Paolo, e dicendo che, mentre l’uomo ha un rapporto diretto con Dio, per la donna questo rapporto passa attraverso l’uomo. Cioè come Dio si rapporta a Gesù Cristo, così Gesù Cristo si rapporta all’uomo e così l’uomo si rapporta alla donna. E purtroppo nel vedere la centralità maschile, le chiese per secoli sono andate d’accordo con la società civile.
Il dibattito è incominciato invece, in modo più vivace, dopo la seconda guerra mondiale: alcuni dicono che questo è dovuto ad una situazione di emergenza. Infatti in alcune comunità, specie in Germania, non c’erano più pastori perché in guerra o prigionieri ed erano sostituiti dalle donne nelle responsabilità delle comunità. Quindi la discussione sul ruolo di queste donne che di fatto avevano già responsabilità nelle comunità è iniziata, ma il riconoscimento pieno arriva soltanto ai nostri tempi. Cito soltanto brevemente il dibattito che nella chiesa valdese si è protratto per ben quattordici anni dal 1948 al 1962.
I sinodi si sono posti il problema se le donne potessero esser considerate pienamente chiamate ad un pastorato femminile o se soltanto come assistenti pastorali; in che modo una donna possa vivere il pastorato; se dovessero vivere da nubili, perché, si diceva, una donna non può essere responsabile per una comunità e nello stesso momento per una famiglia.
Nei sinodi si fondava la tesi del riconoscimento del ruolo delle donne su alcuni passi biblici fondamentali, soprattutto – come potete immaginare – tratti dalla Lettera dell’apostolo Paoloai Galati: «In Cristo non c’è più né giudeo né greco, schiavo o libero, uomo o donna», e questo aspetto è molto più centrale che non altri passi, in cui invece si invitano le donne a tacere nella comunità o in cui si dice che Cristo è il capo dell’uomo, mentre il capo della donna è l’uomo.
E partendo da quel versetto il Sinodo del 1962 finalmente riconosce alle donne di essere chiamate anche loro al ministero, perché in Cristo è stata creata una umanità nuova, che non tiene più conto dell’appartenenza di razza, nazione o genere, ma tiene conto del fatto che siamo tutte persone davanti a Dio, chiamate a vivere la nostra testimonianza. Possiamo dire che la Riforma ha posto le fondamenta del sacerdozio universale, nella riscoperta delle Scritture e perciò anche del comportamento di Gesù verso le donne, nell’istruzione pubblica, nell’apertura del ministero alle donne; cioè per considerare la testimonianza di uomini e di donne nella chiesa sullo stesso livello.
Potrei concludere qui, ma non sareste soddisfatti: siamo ad una bella conclusione, siamo arrivati alla meta! Le donne possono diventare pastore, essere consacrate, rivestire un ministero riconosciuto, assumere responsabilità nelle chiese. Ma purtroppo a questa meta non siamo ancora arrivati, poiché fino ad ora soltanto in alcune chiese protestanti c’è questa possibilità per le donne di non essere soltanto credenti, ma anche predicatrici. Ed è tuttora difficile per le donne vivere questo ministero che per tanti secoli è stato un ministero al maschile. I modelli sono tuttora maschili. E perciò vorrei concludere con una parte un poco più problematica, proponendovi alcune questioni ancora non risolte.
Non è sempre facile per noi donne pastore sentirci a nostro agio in questo ministero femminile, perché comunque il contesto ecclesiale è ancora profondamente maschile. Lo noto soprattutto negli incontri ecumenici (è appena passata la Settimana ecumenica per l’Unità ): spesso sono l’unica donna. Addirittura in alcune situazioni questo crea difficoltà.
Appena arrivata a Milano sono stata invitata dalla Comunità di Sant’Egidio alla preghiera insieme con un padre cristiano della chiesa copta. Ma quando egli ha sentito che insieme a lui sul sagrato ci sarebbe stata una donna si è rifiutato di accettare. E’ chiaro che si aggiunge alla difficoltà teologica anche quella culturale. Meno male che in Europa abbiamo realizzato l’emancipazione delle donne e dobbiamo ringraziare le nostre antenate di aver lottato per farci accettare nella nostra società.
Altre volte invece succede che, come donna pastora, vengo invitata per un motivo folcloristico: cioè fa bello avere una donna fra tutti questi maschi. Infatti quest’anno ho detto apertamente che accetterò soltanto gli inviti finalizzati a portare un annuncio, un contenuto, non per fare bella figura o atto di presenza. Perché il pastorato femminile è un po’ insolito! La partecipazione è sempre una decisione da prendere con cura. In che modo partecipare, come dare una testimonianza che abbia un senso e che possa invitare a condividere la stessa fede in Gesù Cristo.
L’altra domanda che vorrei porre anche a voi: «Ha senso parlare di un modo femminile di vivere la fede? C’è una particolarità delle donne di vivere la loro spiritualità? Noi donne abbiamo un modo diverso di vivere la fede, di annunciarla, di condividerla? Per noi hanno importanza altre cose? O invece le cose fondamentali le condividiamo?
Parliamo un altro linguaggio circa l’uso dei simboli, circa il riferimento ad altre esperienze?». Infatti l’ermeneutica delle donne teologhe ha cercato di scoprire soprattutto il contesto di esperienza delle donne, cioè di non fare teologia in modo teorico-scientifico, ma teologia che possa aiutare le donne di oggi a vivere nel contesto loro concreto.
Annunciare sì il messaggio del Cristo vivente, ma annunciarlo in un modo che possa arrivare alle donne nel loro diverso contesto. E’ chiaro che è importante riscoprire le diverse figure bibliche o le nostre antenate nella fede, perché soltanto così possiamo imparare anche noi lo specifico delle donne, della loro testimonianza.
Altra domanda è: «Che compito, che vocazione potrebbero avere le donne nel dialogo ecumenico o interreligioso?». Qualcuno ha detto che le donne potrebbero diventare portatrici di riconciliazione, di dialogo, in quanto già notiamo all’interno delle diverse religioni che sono le donne che si oppongono alla violenza. Le donne dell’Argentina che con la sola loro presenza hanno cercato di cambiare la politica o di sottolineare il fatto che deve vincere la vita, la giustizia.
O le donne in nero della Palestina e di Israele, che vogliono la riconciliazione e per amore dei loro figli dicono che Dio non è Dio della morte, che chiede sempre il sacrificio del figlio, ma è un Dio che ci offre la vita. Uno dei ministeri delle donne potrebbe proprio essere quello di annunciare la vita, la riconciliazione, di promuovere un dialogo anche fra donne nelle diverse religioni: non è così facile perché nell’ambito dell’islam, ma anche dell’ebraismo, quelli che dialogano ufficialmente sono uomini e le donne restano emarginate.
Per concludere dobbiamo dire che la tradizione delle chiese fino ad oggi preferisce per le donne un ideale di obbedienza invece che un discepolato di eguali; propone il modello dell’aiutante, dell’assistente, della diacona invece che quello dell’apostola, capace di testimoniare. E perciò è importante riscoprire il ruolo delle donne nella Bibbia, nei primi movimenti.
Questo ci può aiutare a far valere la nostra testimonianza, a far sentire la nostra voce, in quanto noi siamo sorelle di una Maria Maddalena, sorelle di queste donne coraggiose che predicavano pubblicamente nelle piazze.
Concludo con l’invito ad usare questa serata per confrontarci sul nostro compito di testimonianza, che è sempre, ma non vorrei essere fraintesa, un compito da svolgere insieme con gli uomini, in chiesa; non in contrapposizione, ma trovando le forme complementari in questa stessa unica Chiesa universale di Gesù Cristo.