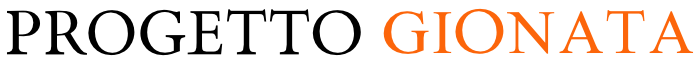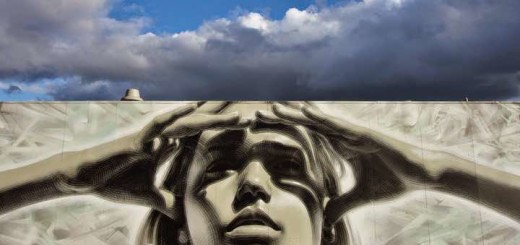Cosa ha da dire la Bibbia sul Gay Pride (Genesi 32, 22-31)
Sermone del reverendo Peter Elliott tratto dal sito della Christ Church Cathedral di Vancouver (Canada), del 31 luglio 2011, liberamente tradotto da Giacomo Tessaro
Di tutte le narrazioni della Bibbia, le storie di Giacobbe e della sua famiglia sono probabilmente le più affascinanti, forse perché il patriarca è un po’ una canaglia: lo stesso nome Giacobbe vuol dire qualcosa tipo “arraffone”, e il suo comportamento vi fa onore. Giacobbe inganna, manipola e mente; è intelligente e disonesto, astutamente infido. Viene alla luce con un gemello primogenito a cui stringe il tallone, in seguito froda il fratello sull’eredità e truffa lo zio Labano, imbroglione quanto lui.
Due storie che lo riguardano in particolare sono celebri: il sogno di una scala (che in realtà è una ziqqurat) che congiunge il cielo con la terra e il racconto di oggi, la sua lotta notturna con uno sconosciuto che lo lascia ferito (Genesi 32:22-31). È in questa storia che a Giacobbe, dopo il suo incontro con lo straniero, viene dato un nuovo nome, Israele. Niente più arraffone, il suo nuovo nome vuol dire all’incirca “colui che litiga con Dio”.
Mentre il racconto di Genesi va avanti ci viene svelata la storia dei suoi figli, con Giuseppe e la sua fantastica tunica dai molti colori. Tutte cose molto adatte a un musical, delle storie che catturano l’immaginazione non raccontando come sono le brave persone ma con la loro penetrante comprensione della natura umana e la loro ricerca di una autentica identità in relazione con il Dio vero e vivente.
La storia di oggi, la lotta con uno sconosciuto e la conseguente ferita, ha trovato una particolare risonanza tra le persone omosessuali, perché in qualche modo cattura un aspetto particolare dell’uscire allo scoperto, dell’essere aperti a proposito della propria identità sessuale.
Forse, mentre nella società crescono la tolleranza e il rispetto per le persone gay, le prossime generazioni avranno a che fare con altri problemi, ma chi tra noi ha un certa età si può identificare con le dinamiche della storia della lotta di Giacobbe con lo straniero e della sua ferita, e devo dire davvero che so cosa vuol dire.
Perché, per molte persone LGBT, la prima consapevolezza del nostro orientamento sessuale arriva come una ferita, un profondo e inaspettato lato della nostra identità con cui lottiamo in silenzio anno dopo anno. Lasciati da parte e non voluti, agonizziamo cercando di capire come possiamo stare al mondo e se troveremo mai qualcuno da amare.
Chi di noi ha una certa età, i più anziani, non trovavano conforto nelle raffigurazioni degli omosessuali nella letteratura e nel cinema: i personaggi gay di Tennessee Williams e altri autori erano sempre figure tragiche, ossessionate dal desiderio sessuale ma incapaci di adattarsi alla società etero che li circondava.
Inclini all’alcool o al suicidio, o ad ambedue le cose, quei personaggi incarnavano gli atteggiamenti dominanti nella cultura nordamericana degli anni ’40 e ’50, con propaggini negli anni ’60 e nei primi anni ’70. Essere gay non era una possibilità contemplata negli anni in cui sono cresciuto.
L’unica possibilità era essere etero, a prestare fede alle immagini popolari del cinema, e crescere avendo come modelli Doris Day e, be’, Rock Hudson.
Così abbiamo seppellito i nostri sentimenti, ci siamo imbarcati in relazioni che non ci consentivano di esprimerci e abbiamo vissuto una vita segreta. Tante donne e tanti uomini sono stati feriti profondamente in quegli anni e ancora oggi, come Giacobbe, attraversiamo la vita, metaforicamente parlando, con un piede zoppo.
Ora grazie a Dio i tempi sono cambiati in questa bella terra del Canada e in molte altre parti del mondo, ma purtroppo la storia del ferimento delle persone gay non è ancora finita.
Riunendoci qui nel giorno della Fierezza Lesbica e Gay siamo consapevoli dei molti posti nel mondo in cui il potere, troppo spesso manipolato dei leader religiosi, criminalizza il comportamento omosessuale e produce generazioni di donne e uomini che vivono nel segreto, letteralmente terrorizzati per la loro sicurezza.
Questo crea un clima di paura che contrasta fortemente con la libertà e l’apertura che le celebrazioni di oggi qui a Vancouver rappresentano. E se le nostre sfilate, il nostro humour, il nostro kitsch confinano pericolosamente con l’osceno agli occhi degli eterosessuali, ricordatevi: quello che è rimasto nascosto per secoli, quando viene rivelato può emergere senza filtri e in modo estremo.
Mi è sempre utile ricordare che la stessa designazione del nostro movimento come “fierezza gay” serve a indicare il suo opposto: molti di noi hanno sperimentato la vergogna gay.
E così abbiamo lottato e vissuto la ferita e siamo emersi, come Giacobbe, con una comprensione totalmente diversa di chi siamo e di cosa possiamo offrire al mondo. Io credo che il viaggio del coming out sia un viaggio spirituale, e grazie a Dio molti cristiani sono ora in grado di testimoniare, ricevere, confermare e benedire i doni delle discepole lesbiche e dei discepoli gay di Gesù Cristo. Dobbiamo ringraziare alcuni dei nostri pionieri per questo.
Uno dei primi profeti della piena accettazione è stato il nostro amico, il defunto arcivescovo David Somerville. Come vescovo diocesano permise al gruppo Integrity di tenere le sue riunioni, cosa che il gruppo ha fatto per oltre trent’anni, fornendo uno spazio protetto a gay e lesbiche per pregare insieme e offrirsi reciprocamente aiuto pastorale.
Solo diciassette anni fa, quando sono stato nominato decano, non era cosa sicura per un sacerdote [anglicano n.d.t.] essere apertamente gay o avere una relazione.
David mi disse che, dopo che fu annunciata la mia nomina, qualcuno lo avvicinò per dirgli “Lo sa che Peter Elliott è gay?” David non fece una piega; rispose “Di che colore ha gli occhi?” Il tizio fu preso alla sprovvista: “Non mi ha sentito? Ho detto che è gay.” David fece un sorriso e disse “Di che colore ha gli occhi?”
Era la sua maniera di dire che essere gay non aveva importanza più di quanta ne avesse il colore degli occhi. Ed era vero e falso al tempo stesso.
Profondamente, pastoralmente e spiritualmente era vero, ma nei termini della cultura dell’epoca non lo era; e che cosa non ha vissuto la Chiesa in questi anni. Chi tra noi credeva nella piena accettazione tra le file della Chiesa assomigliava molto ai discepoli che arrivano da Gesù in mezzo alla folla e dicono “Non ce n’è abbastanza”.
Per i discepoli si trattava del cibo; per chi proponeva l’inclusione nella vita della Chiesa si trattava dei voti al Sinodo o degli sforzi per il cambiamento. Non ce n’erano abbastanza, o così pensavamo, eppure, se pensate ai mutamenti che abbiamo vissuto nella società canadese e nella Chiesa negli ultimi 25 anni dovreste semplicemente dire “Dio sia ringraziato”.
Perché a Dio non interessa se noi percepiamo scarsità: Dio è il buon Dio che benedice abbondantemente quando gli portiamo ciò che abbiamo e gli chiediamo ciò di cui abbiamo bisogno. Nel Vangelo di stamattina (Matteo 14:13-21), quando i discepoli dicono a Gesù che per dare da mangiare a cinquemila persone hanno cinque pani e due pesci, egli dice semplicemente “Portatemeli qui”. Li prende, li benedice, spezza il pane e lo condivide, e ce n’è abbastanza, tanto che ne avanza.
In questo racconto, che compare in tutti e quattro i Vangeli, il miracolo di Gesù consiste nel dimostrare il potere di Dio di trasformare il poco in molto. Gesù prende il pane e dice “Questa è la mia vita – ora ecco cosa ne farete: renderete grazie a Dio perché non appartiene a voi, in primo luogo; lo spezzerete; e lo darete ad altri.”
Questo è il Dio della vita abbondante. Possiamo spezzare le nostre vite e offrirle perché il Dio Vivente è una sorgente eterna di vita. Offriamo le nostre vite e lui ce le restituirà, proprio come il nostro Gesù ha riavuto la sua vita a Pasqua. La vita in abbondanza è l’esperienza di offrire la propria vita e vedersela sempre restituita.
Presa, benedetta, spezzata e condivisa – questa è una spiritualità eucaristica; proprio come il pane viene preso o scelto, benedetto, spezzato e condiviso, così le nostre vite vengono scelte, benedette e spezzate perché noi possiamo essere condivisi. È quello che è accaduto a Giacobbe quando ha lottato tutta la notte con quello straniero; quello straniero è risultato essere un angelo se non il Dio Vivente in persona.
Giacobbe astuto e infido viene trasformato attraverso la sua ferita e diventa il patriarca del suo popolo: il suo nome Israele – colui che litiga con Dio – diventa il nome con cui è conosciuto il suo popolo: un popolo che nella pienezza dei tempi riceve l’incarnazione di Dio, non più uno straniero sfuggente ma la presenza potente che conosciamo in Gesù Cristo.
In Cristo siamo invitati a partecipare alla spiritualità del litigio con Dio, della lotta con il nostro Dio e con la nostra solita identità, dell’essere feriti e del trovare nelle nostre ferite la grazia di vivere autenticamente.
As one as the story of each coming out, in a certain sense it is simply another expression of the archetypal journey towards full humanity. This archetypal spiritual journey consists everything in finding our deepest and most authentic self made in the image and likeness of God.
This journey is a path of great struggle and of profound wounds, if not physical, however emotional or spiritual. That's why Christians tell the story of the suffering, crucifixion and resurrection of Jesus: it is the profound design of life and a way of finding new life.
So on this day, while we meet around writing, hymns and sacraments, we bring our lives entirely, with good things, bad, bad and shameful, in the presence of the one who loves us, chooses us, there, Blessed: we bring our inadequacy and our pain, in any circumstance, to the one who sees us how we are in depth and calls us on a journey of transformation and grace.
And, more important than everything, we make thanks to the source of life for the simple fact that we are here, that we have travel companions and that our wounds and our struggle we owe them to the one who will give us back our life and there He returns in abundance, today and forever. Amen.
.
Original text: Peter Elliott's Sermon On Pride Day