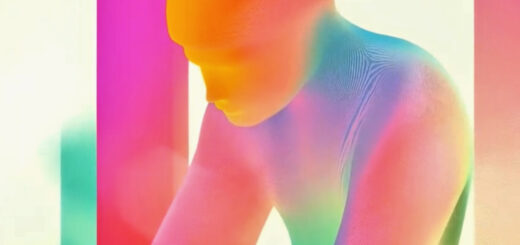Gaycation. Essere omosessuali in India
Appunti di Luciano Ragusa distribuiti durante gli incontri del cineforum del Guado che si sono tenuti il 10 Dicembre 2017
Ecco la scheda con cui. durante il nostro cineforum del 10 Dicembre 2017, è stato presentato il documentario in cui Ellen Page e Ian Daniel, descrivono la condizione delle persone omosessuali in India
Istantanea sull’India
Come ho già avuto modo di scrivere (si veda la scheda pubblicata sul Giappone), non è semplice dare informazioni utili e fruibili sul rapporto che c’è tra omosessualità e società quando si parla di paesi che hanno una cultura molto diversa dalla nostra come il Giappone, la Cina o l’India. In questi casi siamo infatti in presenza di culture che sono tanto ‘sincroniche’ (ovvero caratterizzati da uno sviluppo storico che è durato diversi millenni), quando ‘diacroniche’ (nel senso che questo sviluppo pa percorso tragitti molto diversi da quelli che hanno portato alla nascita della società occidentale contemporanea).
Per capire il senso di un’affermazione di questo genere riguardo all’India, basta osservare i parametri geopolitici più immediati: la popolazione è composta da poco meno di un miliardo e quattrocento milioni di persone che vivono in gigantesche metropoli (la capitale Nuova Delhi, ad esempio, ha diciassette milioni di abitanti); la sua struttura è quella di una federazione composta da 28 stati a cui occorre aggiungere i sette territori amministrati direttamente dal governo federale; la superficie totale della federazione indiana è di 3.287.263 chilometri quadrati (non di molto inferiore a quella dell’Unione Europea); le lingue e i dialetti che vengono usati in questa terra sterminata sono all’incirca mille e cinquecento di cui 22 sono riconosciute dalla Costituzione come lingue ufficiali; l’appartenenza religiosa ha una varietà che non si verifica in nessun’altra parte del pianeta (con più di un miliardo di Hindù; quasi duecento milioni di Musulmani; trenta milioni di Cristiani; ventisei milioni di Sick; dieci milioni di Buddisti; cinque milioni di Giainisti).
A questa istantanea dell’India contemporanea occorre aggiungere una narrazione storica che copre quattro millenni basti pensare che la grande maggioranza degli storici tende a datare la nascita di una società urbana nella valle dell’Indo a circa 1200 anni dalla composizione dei Veda (i più antichi testi sacri dell’Induismo) che, a sua volta è collocata nel XX° secolo prima di Cristo.
Oggi si è propensi a ritenere che la presenza di esseri umani itineranti in questa porzione del continente asiatico, risalga a trecentomila anni fa e che nel quarto millennio prima di Cristo sia iniziato un processo che avrebbe portato alla nascita della cosiddetta Civiltà della Valle dell”Indo, caratterizzata da dallo sviluppo dell’agricoltura, dall’uso della scrittura e, soprattutto, da un’urbanizzazione che precede quella che si osserva in altre parti del pianeta (in particolare in Egitto e in Mesopotamia). L’arrivo, all’inizio del XX millennio prima di Cristo, di una popolazione indoeurpea proveniente dall’Asia Centrale, portò all’introduzione della lingua sanscrita e alla nascita della religione Hindù che sarebbe diventata di lì a venire, la religione dominante, nonostante la nascita del Buddismo nella seconda metà del V° secolo avanti Cristo, la ristrutturazione del Giainismo compiuta da Mahavira verso la metà del V° secolo prima di Cristo e l’invasione islamica (che risale ai primi decenni del XIII° secolo dopo Cristo).
Inutile dire che in questo vastissimo arco temporale che porta ai giorni nostri, concentreremo la nostra attenzione solo su alcuni punti che sono imprescindibili per la comprensione della galassia LGBT indiana. In particolare ci soffermeremo sulla formazione delle caste, ancora oggi criterio dietro al quale si giustificano sia l’equilibrio della società civile, che la possibilità, per esempio, di essere Hijra, cioè di appartenere a quello che potremmo definire con grossa approssimazione “il terzo sesso”. Daremo poi spazio ad alcuni aspetti del colonialismo inglese a cui si deve l’introduzione dell’articolo 377 del codice penale, che prevede punizioni importanti per chiunque viene sorpreso a compiere “atti di sodomia”. Ci occuperemo infine della storia recente, con la cancellazione, nel 2009, dell’articolo 377 e con la sua successiva reintroduzione nel dicembre del 2013.
Prima di dedicarci a questi argomenti vale però la pena ricordare che l’India è uno stato fedeale con un regime parlamentare bicamerale (le due camere si chiamano Camera alta e Camera bassa) secondo quanto disposto dalla costituzione del 1950. Il presidente della Repubblica ha un mandato di cinque anni ed è eletto da membri dei parlamenti federali e statali. Il potere esecutivo è esercitato dal primo ministro e dal consiglio dei ministri, responsabili nei confronti della Camera bassa. É infine il caso di notare che, fin da quando, nel 1947, ha ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito, l’India ha goduto di una notevole stabilità politica, con elezioni periodiche, regolari e democratiche.
La nascita delle caste
«L’abitudine di classificare e di gerarchizzare (che tutto sommato indica negli intellettuali, oltre la debolezza razionale, la tipica dolcezza e umiltà degli indiani) deriva da quell’atroce archetipo mentale che informa di sé ogni atto del pensare e dell’agire indiano: il principio di casta» (Cfr. Pier Paolo Pasolini, L’odore dell’India, Guanda, Parma, 1990, pp. 88-89).
Nella regione del Punjab – letteralmente “cinque fiumi”. tra Indo e Gange – una cultura preistorica del ceppo indoeuropeo, gli Arya, malgrado non abbia lasciato resti materiali, ha prodotto testi rituali conservati per millenni dai sacerdoti. Da queste fonti si evince che la civiltà ariana si diffuse dal Punjab verso sudest, lungo il corso dei fiumi Yamuna e Gange, fino a raggiungere l’Oceano Indiano e l’isola dello Sri Lanka. La sua elìte si definiva pura (arya appunto), e guidava gruppi parentali organizzati in tribù nomadi dedite all’allevamento equino. Questi documenti religiosi, definiti Veda da cui nascerà l’Induismo sono scritti in Sanscrito, la lingua in cui sono scritti anche gli inni cantati nei rituali vedici dedicati alle divinità ariane, la grammatica antica più importante della lingua sanscrita è l’Astadhyayi di Pannini, e viene fatta risalire alla seconda metà del IV secolo prima di Cristo.
Essere ariano significava in sostanza appartenere ad una minoranza privilegiata nell’ambito delle tribù pastorali. I testi che tramandano questo sapere non sono databili con precisione, tuttavia sarebbero venuti alla luce intorno al 1200 a.C., in quattro collezioni di inni vedici: Rg, Sama, Yajur e Artharva. A seicento anni di distanza dai primi Veda, compaiono i trattati rituali Brahmana e numerosi componimenti mistici filosofici tra cui l’Aranyaka e le Upanishad, che descrivono una cultura ormai diffusasi largamente a est del bacino del Gange.
Due poemi epici: Ramayana e Mahabharata, probabilmente, si riferiscono invece probabilmente a guerre tribali combattute nella prima metà del I millennio avanti Cristo, sullo spartiacque tra Indo e Gange; si tratta però di opere composte a distanza di molti secoli dai conflitti narrati, e oggetto di svariate aggiunte e rimaneggiamenti nei secoli successivi.
Venendo al nocciolo della questione, il corpus delle fonti più antiche, esprimevano una cultura del brahmanesimo vedico nella quale, i rituali sociali, prescrivevano ai governanti di proteggere e imporre un ordinamento stratificato basato su quattro varna (letteralmente colore) su cui si sarebbero cristallizzate le caste.
La parola è già presente nel primo dei quattro inni vedici, il Rg, infatti, narra di Purusa, un uomo primordiale dal cui sacrificio e smembramento nascerà tutto il creato e, quindi, anche le caste, che trovano così la loro giustificazione mitologica e religiosa. In questa classificazione in varna sono così suddivisi:
Brahmani, sacerdoti e intellettuali che conoscono gli scritti sacri e possono compiere funzioni spirituali e sacrifici. Il colore associato è il bianco, che significa luce e purezza;
Kshatriya, guerrieri e nobili che governano e proteggono altri uomini. La tinta di riferimento è il rosso, che richiama il sangue e il fuoco;
Vaisya, mercanti e artigiani che si occupano della produzione di beni e del commercio. Il giallo/bronzo è l’incarnato ad essi riferito;
Shudra, servitori di tutti gli altri la cui nuance è il nero.
Ma fuori dalla sfera strettamente religiosa qual è l’origine delle caste?
La tesi prevalente rimanda il sorgere di questa complessa elaborazione sociale all’arrivo degli Arya e all’inevitabile incontro tra loro, conquistatori, e le popolazioni dravidiche conquistate. Nel 1946 fu lo stesso Nehru, divenuto Primo Ministro della nascente Repubblica Indianaa sostenere all’indomani della dichiarazione di indipendenza. che, malgrado le popolazioni conquistate vantassero un patrimonio culturale straordinario e di antichissima origine, i nuovi arrivati si posero fin da subito in atteggiamento superiore, all’interno della tipica dialettica tra vincitore e vinto.
Il solo modo per ottenere pieno controllo sulle terre invase, senza doversi preoccupare di interagire con le popolazioni già presenti sul territorio, era sottometterle creando una barriera tra i bianchi conquistatori e gli autoctoni di pelle più scura.
Successivamente, l’appartenenza, divenne più una questione legata alla professione che alla nascita, ed esisteva anche una certa intercambiabilità tra caste. In concomitanza con l’emergere di nuove e sempre più diversificate attività lavorative ci fu il conseguente sorgere di ulteriori caste e sottocaste, che diede luogo a una frammentazione minuziosa della struttura sociale (jati).
Ai quattro varna ufficialmente riconosciuti si aggiunse una quinta categoria, detta a-varna (senza colore), che raggruppava tutti coloro che erano considerati talmente inferiori da non possedere nessuna tinta, depositari del più alto livello di impurità e, per questo, isolati ed emarginati. In altre parole, si tratta degli “intoccabili”, i parìa che, in India non solo sono di casta bassa, ma che erano anche esclusi dai programmi educativi ed occupazionali, poiché la loro impurità era fonte di allontanamento e di esclusione dalla società.
Nel corso della storia sociale e politica dell’India, furono molti i riformatori e gli intellettuali che alzarono la loro voce contro la rigidità del sistema castale e contro il trattamento inumano nei confronti delle caste basse. In tempi recenti riformatori come Raja Ram Mohan Roy e Gandhi, per citare i più celebri, si sono battuti affinchè l’intoccabilità cessasse. E fu proprio Gandhi a ribattezzarli con l’appellativo di harijan (che significa “figli di Dio”).
Un epifenomeno, che nel corso dei secoli ha fatto davvero la differenza, legato alla sottoclassificazione dei ceti lavorativi, è il diffondersi dei comportamenti endogamici: poche righe sopra abbiamo accennato all’intercambiabilità tra le caste, possibilità che è progressivamente venuta meno per via della consuetudine dei matrimoni combinati all’interno dello jati di provenienza; purtroppo, l’idea sottesa dietro a questo atteggiamento riguarda l’ordine e l’equilibrio sociale, minato alle fondamenta, qualora si consentissero unioni tra persone che si amano piuttosto che tra membri di una classe sociale.
A ciò, si deve aggiungere la discriminazione nei confronti di chi, per caratteristiche e qualità personali, si sente più vocato a svolgere una professione diversa rispetto alla stratificazione dalla quale è nato: in uno dei libri della tradizione postvedica, Libro di Manu, si recita che «è meglio fare male il proprio lavoro piuttosto che fare bene quello di un altro», bocciando apriori la possibilità che il figlio di un falegname possa diventare un impiegato o che il figlio di un insegnante possa diventare un cuoco.
Al di là dei diversi tentativi che le istituzioni indiane hanno fatto per abolire il sistema delle caste, queste continuano a sopravvivere nella società come tradizione e sono riuscite a condizionare la morfologia stessa di alcuni partiti politici tant’è che la maggior parte dell’agone pubblico è speso per difendere privilegi che arrivano da lontano, e che sono figli di un reticolo cristallino che affonda le radici nella più antica memoria del popolo indiano.
Per quanto riguarda l’universo LGBT, malgrado la documentazione sia scarsa, non è difficile ipotizzare che il sistema di classi e sottoclassi abbia influenzato i rapporti tra persone dello stesso sesso. Molti omosessuali, sebbene consapevoli in senso occidentale della propria condizione, continuano ad aderire agli usi e ai costumi del paese natio, sacrificando la propria felicità.
Occorre poi osservare che il Kamasutra («libro del piacere e del desiderio»), un classico della letteratura erotica induista databile tra il I e VI doop Cristo, riporta alcune posizioni che sembrano riferirsi a rapporti lesbici e gay anche se, alla luce di quello che succede nella società indiana, sembra che questi riferimenti siano più legati alla subcultura , ma probabilmente, più riferiti al mondo della subcultura Hijra (di cui parleremo tra poco) che a vere e propri relazioni affettive tra persone dello stesso sesso.
Insostanza si può dire dell’Induismo la stessa cosa che si è detta per lo Shintoismo quando abbiamo parlato del Giappone, ovvero che non è sufficiente non trovare passi che condannano l’omosessualità per affermare che una religione non generi degli atteggiamenti omofobi nelle persone omosessuali e nelle persone che, con gli omosessuali, hanno a che fare.
La subcultura degli Hijra
Nel poema epico Ramayana, si narrano le gesta del dio Rama, considerato nella religione induista come avatara (ovvero una divinità discesa sulla terra per ripristinare l’ordine) del dio Visnù. Si racconta che Rama, per volontà paterna, partì verso la foresta dove avrebbe trascorso i successivi quattordici anni in esilio. Lo seguirono in molti, uomini, donne, il fratello Lakshmana e la moglie Sita. Quando si accorse della moltitudine che l’aveva seguito, la radunò e suggerì loro di non preoccuparsi e di fare ritorno nella città di Ayodhya, dove avrebbero dovuto attenderlo nella pace e nella serenità del regno.
Trascorso il tempo previsto, dopo anni di imprese e di avventure, il grande dio vittorioso si rimise in cammino verso il palazzo e, lungo il percorso, si imbattè in una comunità di fedeli che era rimasta ad aspettarlo nello stesso luogo in cui li aveva congedati quattordici anni prima: erano gli Hijra, né uomini né donne, i leggendari eunuchi della storia antichissima. Impressionato dalla devozione dimostratagli, Rama conferì loro il potere di benedizione in occasione dei due momenti più importanti della vita di ogni indiano: la nascita e il matrimonio.
La parola Hijra è praticamente intraducibile: si sospetta un’etimologia araba, legata al termine hir, il cui significato è «lasciare la terra della tribù»; presa poi in prestito dalle infinite lingue e dialetti che percorrono l’intera Asia del Sud, la parola ha assunto, e assume tuttora, connotazioni e significati territoriali moto differenti.
In alcune zone è sinonimo di “terzo sesso”, in altre di prostituti; per certe comunità potrebbe significare «persone che non hanno né genere né identità»; in altre ancora ne viene esaltato il carattere sacerdotale.
La cosa è estremamente interessante soprattutto per noi occidentali, abituati come siamo a organizzare tassonomie di ogni tipo e che poi dobbiamo fare i conti con manifestazioni della condizione umana che non rientrano in nessuna delle definizioni che abbiamo partorito in occidente e che abbiamo iniziato a elencare nel lunghissimo acronimo: LGBTQIA (e che più ne ha più ne metta di lettere nel tentativo di inquadrare in un’unico schema le situazioni più differenti).
Ma chi sono allora questi “eunuchi” della tradizione induista?
La maggior parte degli Hijra sono maschi che, a causa della loro omosessualità (che potrebbe però anche non essere determinante), o dei loro atteggiamenti effemminati, o di qualche forma di ermafroditismo, entrano in una delle comunità di “evirati” definite dalla antica consuetudine vedica o per scelta proprio, oppure perché cacciati dalle famiglie e abbandonati al loro destino.
I nuovi arrivati, nella maggior parte dei casi, debbono sottoporsi ad un rito che consiste in una forma di castrazione chirurgica che termina con l’attribuzione di un nuovo nome da parte del guru della comunità. Si tratta di un vero e proprio rito iniziatico con importanti implicazioni religiose, affidato a una levatrice che con le lame taglienti di un rasoio e senza alcun tipo di anestesia, taglia lo scroto e castra il novizio.
All’operazione, che viene effettuata tra le tre e le quattro del mattino, in concomitanza con il passaggio dalle tenebre alla luce del giorno, segue l’iniziazione religiosa del neofita da parte del maestro più anziano che, con una puja (offerta rituale), consacra l’ultimo venuto a Bahuchara Mata, la dea protettrice della comunità. Le ore che seguono la castrazione sono le più critiche, perché l’emorragia provocata dall’evirazione non viene in alcun modo arginata: si crede, infatti, che il sangue simboleggi la mascolinità dell’uomo che abbandona il corpo. Al contrario, viene inserito un piccolo bastoncino nell’uretra per evitare la sutura della ferita, e soltanto l’applicazione di olio caldo sulla lesione ne scongiura l’infezione.
Il nuovo nato, divenuto ufficialmente un Hijra consacrato a Bahuchara Mata, prenderà un nome iniziatico femminile, sarà addestrato alla danza e al canto, e riceverà insegnamenti religiosi dal proprio maestro.
Malgrado non abbiano più i genitali maschili, vengono considerati simbolo della fertilità, ed invitati nei matrimoni, in cambio di offerte, per benedire le nuove unioni attraverso canti e balli della tradizione rituale. Lo stesso ufficio viene loro affidato alla nascita di un figlio maschio, che viene benedetto dagli Hijra affinché abbia un futuro prospero.
Da questa descrizione, seppur sintetica, si evince la difficoltà di catalogare questa subcultura: gli Hijra, infatti, non possiamo considerarli transessuali, transgender, crossdresser o queer, perché tutte queste definizioni non terrebbero conto del significato che loro hanno nella cultura indiana. Nesusno di lor, per esempio, dopo la castrazione, pensa di sottoporsi a un intervento chirurgico per avere dei genitali femminili, perché un Hijra non si sente una donna, Ma anche la definizione di travestito o di trangender non la sentono come propria, perché non comprende il valore religioso della loro condizione. Ancora una volta siamo di fronte a situazioni che vanno al di là delle modalità con cui noi descriviamo l’identità di genere e l’orientamento sessuale in occidente.
Negli ultimi due secoli le condizioni di questa minoranza sessuale sono progressivamente peggiorate, principalmente in seguito all’imposizione dell’ordinamento coloniale anglosassone. Dopo l’arrivo degli inglesi il ruolo mitologico degli Hijra, si è progressivamente impoverito, costringendo i suoi membri a forme di sopravvivenza legate alla prostituzione e all’elemosina, trasformando una marginalità sociale che aveva un suo prestigio legato alla religione e al culto, in una vita periferica, perché fuori da schemi economici produttivi.
La cosa non è di poco conto, l’introduzione nel codice penale indiano dell’articolo 377, che punisce, i rapporti tra le persone dello stesso sesso, ha visto negli “eunuchi per tradizione” un bersaglio facile da colpire.
Nei primi anni 2000, grazie all’impegno dell’attivista transgender Indiana Laxmi Narayan Tripathi, gli Hijra sono riusciti a strappare al governo promesse circa l’uguaglianza sociale e il riconoscimento del loro status. Le loro comunità hanno poi iniziato a difendere in prima persona il loro stesso diritto all’esistenza, formando comitati e impegnandosi nella vita attiva dei villaggi e delle periferie in cui risiedono, raggiungendo l’obiettivo di far eleggere alcuni membri della comunità in ruoli equivalenti a quello di un sindaco occidentale.
Grazie poi all’intervento di alcune ONG e all’interessamento nazionale ed internazionale, il 5 aprile 2014, più di cinque milioni di Hijra hanno potuto festeggiare una storica vittoria legale: la Corte Suprema Indiana, ha riconosciuto loro, e alla più ampia comunità transgender, lo statuto di “terzo genere sessuale” davanti alla legge, garantendo i medesimi diritti che la Costituzione sancisce per il resto della popolazione, e riservando loro lo status di Other Backward Class, ovvero di gruppo sociale che gode di misure governative ad hoc in ambito lavorativo e scolastico.
Bagni pubblici specifici, reparti ospedalieri pensati appositamente per loro, documenti d’identità con la dicitura “terzo sesso”, stanziamento di un determinato numero di posti riservati nei luoghi d’impiego statali, nelle scuole primarie e nelle università, secondo il sistema delle quote riservate già in vigore per le altre classi svantaggiate, sono alcune delle conseguenze pratiche di una legge che punta dritta all’uguaglianza.
Naturalmente, tra il verdetto, e l’effettiva applicazione della sentenza, ci sono parecchie discrepanze, e i tempi di applicazione della legge saranno lunghi, anche perché dovranno fare i conti con le resistenze di un intero paese che, pur essendo progressista e pluralista sulla carta, è invece estremamente conservatore.
Lo strano caso dell’articolo 377 del Codice penale indiano
La sentenza con cui la Corte Suprema indiana ha riconosciuto l’esistenza di un “terzo sesso” è in aperto contrasto con un’altra decisione che ha portato alla reintroduzione del famigerato articolo 377 del codice penale indiano che condanna i rapporti omosessuali e che era stato derubricato nel 2009. Ma andiamo con ordine.
L’introduzione dell’ordinamento inglese fu uno spartiacque decisivo nella storia della società indiana. La Compagnia delle Indie Orientali, che aveva governato su alcune parti dell’India durante il Settecento, si adoperò per introdurre un’amministrazione politica e giudiziaria autonoma rispetto all’Impero britannico. Infatti, i primi governanti inglesi, ebbero cura di non introdurre norme di “Sua Maestà britannica” sul suolo indiano, non volendo interferire col funzionamento della società indigena.
Quando la compagnia di navigazione fu costretta a cedere il passo alla politica imperialista della madrepatria, l’India, servì da laboratorio per sperimentare nuovi modelli di regolamentazione e di governo che stavano emergendo in Gran Bretagna, per esempio quelli proposti dagli utilitaristi, ai quali appariva incomprensibile una società fondata su consuetudini non scritte e sul governo della discrezionalità personale. Essi pensavano che ci fosse un solo metodo sicuro per separare gli interessi pubblici da quelli privati, ovvero l’introduzione di un sistema di legalità nel quale i diritti fossero definiti da un codice di leggi scritte, vincolanti sia per lo Stato che per i suoi sudditi.
Tutto il contrario di quello che succedeva in India, dove era invece l’adesione ad un sistema religioso, quello induista, coi suoi insegnamenti, a reggere l’architettura sociale dei territori, non c’era quindi l’esigenza di un operatore laico come lo Stato che impartisse leggi univoche per tutti.
Dopo discussioni e tentativi durati un secolo, nel 1860, si giunge a promulgare una serie di codici, tra cui il codice penale la cui stesura, operata da Lord Macaulay quando (tra il 1834 e il 1838) era membro del Consiglio Supremo dell’India, era il frutto di una gestazione durata più di venti anni. All’interno di quel codice, compariva, per la prima volta in India , un articolo di cui riportiamo di seguito il testo: «chiunque volontariamente abbia rapporti carnali contro l’ordine naturale, con qualsiasi uomo, donna o animale, è punito con la reclusione per la vita, o con la reclusione o altra pena per un termine che può estendersi sino a dieci anni, ed anche passibile di multa». La norma era cntenuta nel Capitolo XVI che parlava «Delle offese al corpo umano» ed era rubricata sotto il titolo: «Delle offese innaturali».
La base giuridica di questo articolo era il Buggery Act, la prima legge inglese espressamente costruita per condannare la sodomia, promulgata nel 1533 ad opera di Thomas Cromwell. Nel 1860, il viceré dell’India era James Bruce (figlio del settimo Conte di Elgin che sarebbe passato alla storia per aver portato a Londra i marmi del Partenone) e la sua preoccupazione era che i funzionari e i soldati imperiali si lasciassero corrompere da certi vizi “orientali” fino a soccombere alle “tentazioni di Sodoma e Gomorra”. A detta di Sir Bruce i comportamenti omosessuali tra il personale coloniale inglese era piuttosto diffuso e veniva sperimentato senza troppi sensi di colpa.
Il guaio è che, dopo aver raggiunto la sua indipendenza nel 1947, l’India ha mantenuto gran parte del codice penale di Lord Macauly, e quindi anche l’articolo 377 che è sopravvissuto fino al 2009, quando l’Alto Tribunale di Nuova Delhi lo ha depennato. La scelta però non è stata indolore, perché molti ministri spacciavano l’ipocrisia vittoriana del XIX secolo per la morale induista e sostenevano che il Buggery Act, quando fu introdotto, rispondeva ai valori e ai costumi dell’India.
In realtà questi politici soffrivano di una vera e propria amnesia storica, perché è un fatto oggettivo che l’India, così come la maggior parte delle ex colonie britanniche che puniscono i comportamenti omosessuali, lo fanno in virtù di leggi introdotte dal governo inglese, e non per mettersi in sintonia con gli usi e i costumi tradizionali.
Pakistan, Bangladesh, Uganda, Nigeria, Zimbawe, Tonga, Papua Nuova Guinea, Singapore sono paesi con tradizioni religiose diversissime tra loro, e tutti, prima dell’arrivo degli inglesi non prevedevano punizioni contro gay e lesbiche.
Nel 2008 l’Osservatorio per i Diritti (un’organizzazione che si batte per i diritti umani), ha pubblicato un rapporto di sessantasei pagine dal titolo The Alien Legacy (“L’eredità aliena”) in cui si contesta la pretesa che questi governi accampano di considerare “abitudine storica” la condanna penale dei comportamenti omosessuali e invoca protezione da parte dell’ONU delle differenti identità di genere e degli orientamenti sessuali diversi dall’eteronormatività.
Dunque, nel 2009, l’articolo 377 del codice penale è stato derubricato con la seguente motivazione: «La sezione di cui sopra, nella parte in cui criminalizzava rapporti sessuali consensuali tra adulti dello stesso sesso, è violativa di tre diritti e principi costituzionali, quali il diritto alla vita ed alla libertà personale (articolo 21), il diritto all’eguaglianza (articolo 14), e il divieto di discriminazione basato su ragioni di religione, razza, casta, sesso e origine (articolo 15)».
Per quattro anni la comunità LGBT indiana ha potuto godere di una maggiore libertà, iniziando un percorso di visibilità che la stava progressivamente allineando all’esperienza di tanti altri movimenti arcobaleno in varie parti del mondo.
Nel dicembre 2013, però, la Corte Suprema, ha reintrodotto il castigo contestando all’Alto Tribunale di Nuova Delhi la competenza per depennarlo e invitando l’esecutivo a legiferare in materia.
Anche ammettendo la buona fede della Corte Suprema è un dato innegabile che, in questi quattro anni, non ha fatto nulla per colmare il vuoto legislativo che la sentenza del 2013 ha creato. Se ci riuscisse consentirebbe un definitivo cambio di passo che permetterebbe di salvaguardare l’esistenza di lesbiche e gay, perché una cosa è senz’altro chiara: la morale popolare e la pubblica disapprovazione non sono valide giustificazioni per limitare dei diritti costituzionalmente protetti.
Ma sulla capacità della politica di dare una risposta positiva al problema della eliminazione dell’articolo 377 del Codice penale è lecito avere molti dubbi, perché, se le religioni indiane (induista, musulmana e cristiana in primo luogo) fanno convergere il proprio potere numerico, diventa politicamente impossibile ottenere questo risultato.
L’auspicio è che l’attuale vocazione dell’India alla globalità economica, si traduca presto in una estensione dei diritti, con la consapevolezza, che norme come l’articolo 377, non hanno motivo di esistere in nessun luogo del mondo.
Bibliografia
Della Casa Carlo, Piantelli Mario, Piano Stefano, Hinduismo, Laterza, Bari, 2007.
Ludden David, Storia dell’India e dell’Asia del Sud e del Sud Est asiatico, Einaudi, Torino, 2011.
Pasolini Pier Paolo, L’odore dell’India, Guanda, Parma, 1990.
Piano Stefano, Lessico elementare dell’induismo, Manganelli, Torino, 2001.
Som Reba, La nascita dell’India moderna, Castelvecchi, Roma, 2009.
Torri Michelguglielmo, Storia dell’India”, Laterza, Bari, 2007.
Shahani Parmesh, Gay Bombay, SAGE Publication, New Delhi, 2008.