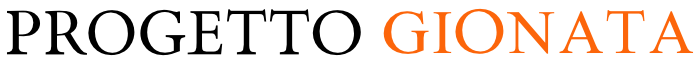La donna invisibile: come gli uomini hanno nascosto l’umanità di Maria
Riflessioni di Katy Hessel* pubblicate sul sito del quotidiano The guardian (Gran Bretagna) il 20 dicembre 2024, liberamente tradotto dai volontari del Progetto Gionata
Quanto conosciamo davvero della vita della Vergine Maria? In qualsiasi paese cattolico, chiesa o museo europeo, la sua immagine è onnipresente: è il ritratto ideale di una donna obbediente, pura, casta, raffigurata spesso con le mani giunte o con suo figlio in grembo, come regina dei cieli o seduta umilmente nella natura. Vestita sempre di blu, simbolo di purezza, ad incarnare la pietà e il ruolo imposto dal sistema patriarcale: quello di una donna subalterna e silenziosa.
Maria è forse la figura femminile più rappresentata nella storia dell’arte e della cultura, ma è anche avvolta da un’aura di mistero e di contraddizioni: umana e divina, madre e vergine, regina e serva. Eppure, nonostante la sua presenza onnipresente nell’arte, la sua storia personale è quasi assente. È davvero la sua voce quella che ascoltiamo nei racconti che ci sono stati tramandati?
Un’assenza che parla
Nei Vangeli canonici, non ci sono dettagli sulla nascita, la morte, l’aspetto o l’età di Maria. Luca e Matteo parlano di lei nella natività di Cristo. In Matteo, Maria è muta, mentre in Luca parla tre volte, incluso il suo potente Magnificat. In Marco e Giovanni appare solo due volte. Tuttavia, in tutta la Bibbia non ci viene raccontata alcuna storia di Maria. Gli unici “dettagli” al di fuori del suo ruolo di madre di Cristo sono contenuti nel Vangelo di Giacomo, un testo apocrifo del II secolo. Paradossalmente, Maria è menzionata più volte nel Corano che nel Nuovo Testamento.
Perché la sua storia è assente? Perché gli autori dei Vangeli intendevano raccontare la storia di Gesù Cristo, non quella di sua madre, lasciando spazio ai Padri della Chiesa e ai teologi per creare elaborazioni e interpretazioni. Anche gli artisti, a loro volta, hanno dato le proprie interpretazioni.
Hilary Mantel descrive Maria come “l’improbabilità al cuore della vita spirituale; un paradosso, non fecondata ma generatrice, al di sopra della natura ma anche contro natura”. Afferma che la sua natura di madre e vergine fu “un’eccezione divina, un’opportunità unica per la carne femminile di purificarsi e diventare accettabile agli occhi degli uomini celibi che decidevano chi avrebbe avuto accesso al paradiso”.
Maria nell’arte: da icona divina a donna idealizzata
Attraverso i secoli, l’arte ha trasformato Maria in un simbolo. Nel IX secolo era una figura astratta e divina nei mosaici bizantini, come quello di Santa Sophia a Istanbul. Nel XIII secolo, Cimabue la raffigurava nella sua Maestà gotica, seduta su un trono in un mondo dorato. Con Giotto, nella Madonna di Ognissanti del 1310, Maria assume un aspetto più umano: la sua carne si intravede sotto le vesti, e l’opera segna un punto di svolta verso l’arte rinascimentale.
Nel corso dei secoli, però, Maria viene sempre più idealizzata. Verso il 1500, la sua immagine si consolida in Occidente come quella di una donna bianca, borghese, vestita di blu, amorevole verso il suo bambino, una donna che incarna l’ideale di obbedienza, purezza e sottomissione.
Ma cosa pensava Maria? Quali emozioni provava? La storia che lci racconta l’arte è stata quasi sempre narrata da uomini, e la prospettiva femminile è praticamente assente. Così, questo Natale, voglio vedere a Maria attraverso lo sguardo delle donne artiste che l ‘hanno raffigurata.
Uno sguardo femminile su Maria
Artemisia Gentileschi, in Italia tra il 1613 e il 1614, dipinse una Madonna col Bambino molto diversa. La sua Maria è umile (seduta su una semplice sedia di legno) e divina (con una sottile aureola dorata), ma anche profondamente umana. Indossa il rosa invece del tradizionale blu e viene mostrata mentre tenta, persino a fatica, di allattare un bambino paffuto dai capelli dorati. Il suo viso trasmette amore e tenerezza, ma i suoi occhi chiusi e i capelli in disordine suggeriscono che è esausta, come qualsiasi madre. È un’immagine che dista anni luce dal ritratto freddo e quasi robotico del Dittico di Melun di Jean Fouquet (1452).
Ma forse la rappresentazione più potente di Maria è quella di Paula Rego. Nel 2002, su richiesta del presidente portoghese Jorge Sampaio, Rego reinterpretò la storia di Maria dal punto di vista di una donna reale. “Come si può aggiornare la sua storia? In un certo senso, non si può, ma si può raccontarla dal punto di vista di una donna… di Maria che racconta la sua storia”, disse l’artista.
Rego colloca Maria sopra a Cristo, dando vita alle sue esperienze. La sua Annunciazione mostra un angelo dalle ali soffici che consegna il messaggio a una Maria giovane, ansiosa e timorosa.
Ti chiedi: com’è stato per lei? Era pronta? Quanti anni aveva? Rego vestì Maria come una scolara e usò la sua nipote dodicenne come modello. “E’ spaventata e accetta allo stesso tempo”, spiegò Rego, che come madre aveva vissuto in prima persona l’esperienza della gravidanza, a differenza degli artisti uomini.
In un’altra opera, la Natività, Rego ritrae Maria stremata, che si stringe il ventre gonfio, appoggiata a un angelo, gli occhi chiusi dal dolore. Rego ci costringe a chiederci: perché la realtà del parto è stata esclusa dall’iconografia di Maria?
Perché questo suo unico suo “atto” – dare alla luce Gesù – non è mai stato rappresentato?
Nel 2023, in una chiesa di Linz, qualcuno è stato così sconvolto da una scultura di Esther Strauss che mostrava Maria partorire da decapitarla.
Restituire voce a Maria
La prossima volta che guardi un presepe, un dipinto della Madonna col Bambino in una galleria o su una cartolina di Natale, pensa a Maria. Cosa stava vivendo? Quali erano i suoi pensieri?
Sono mondi lontani da quelli di una donna passiva e inespressiva, come quella della cattedrale di Ely.
È tempo di restituire a Maria la sua umanità. Le storie delle donne contano, così come le loro prospettive.
*Katy Hessel è una storica dell’arte e conduttrice britannica. È l’autrice del libro The Story of Art Without Men (Penguin Books, 2022), un testo che esplora la storia dell’arte mettendo in luce artiste donne spesso dimenticate o trascurate. Il suo lavoro si concentra sulla rivalutazione del contributo delle donne nella storia dell’arte, rompendo le barriere di genere e promuovendo una narrazione inclusiva. Katy Hessel è anche nota per il suo podcast The Great Women Artists, in cui intervista artiste, curatrici e storiche dell’arte per discutere delle loro esperienze e opere.
Testo originale: There’s nothing meek or mild about childbirth: why have male artists sanitised the Virgin Mary?