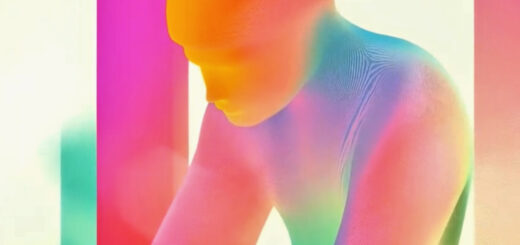Il cinema di Dreyer.Indipendentemente dalla disciplina di cui si vuole scrivere, esistono personaggi i cui nomi impongono un immediato timore reverenziale, come se il rispetto per ciò che hanno regalato impedisse di esprimere un’opinione su di loro, in una sorta di conversazione a due voci sempre sbilanciata, per paura di dire castronerie, a favore dell’autore preso in considerazione.
Carl Theodore Dreyer, cineasta danese nato nel 1889, appartiene alla schiera di questi personaggi, alcune delle pellicole da lui firmate, infatti, sono annoverabili tra le più importanti opere d’arte in senso generale, non solo capolavori del cinema. La passione di Giovanna d’Arco, per esempio, uscito nel 1928, è un lungometraggio che, insieme ai romanzi di Kafka e Mann, l’Ulisse di James Joyce (1922), l’Urlo di Edvard Munch (l’ultima versione è datata 1910), ed altri capolavori del teatro e dell’architettura, risulta indispensabile per capire la stagione culturale che definiamo “Espressionismo” e che esaurisce la propria propulsione negli anni in cui prende forma la pellicola di Dreyer.
Non siamo dunque di fronte ad un regista tra i tanti, bensì ad un pensatore che ha provato a piegare le potenzialità della “settima arte” alla propria grammatica, costituita da un’estetica rigorosa che non presenta dissimmetrie, mediata da una coerenza mai banale.
Inutile elencare i cineasti che si sono sentiti, o si sentono, debitori di Dreyer (tra questi Pasolini, che lo considera, insieme a Mizoguchi e Chaplin, il suo maestro), così come è superfluo elencare filmografia e notizie biografiche, del resto facilmente reperibili coi mezzi a disposizione di noi tutti. Molto più interessante è sapere che Dreyer, oltre a girare film, ha svolto per tanti decenni il mestiere di giornalista cinematografico, fatto che ha reso i suoi articoli un’opera tra le opere, nella quale, confrontandosi con altri lungometraggi e registi, fornisce una visione completa della sua idea di cinema.
Allora, piuttosto che avventurarmi in analisi complesse (il timore d’inizio pagina?), ho deciso di proporre alcuni stralci dei suoi articoli particolarmente significativi e utili per comprendere la visione di Mikaël, l’opera che è al centro della nostra proiezione di oggi (tutti i testi sono riportato dal libro curato da Camillo Bassotto: Carl Theodor Dreyer: I miei film, Edizioni Cineforum, Venezia, 1965).
.
«Il vero film parlato» (da Politiken del 19 novembre 1933, cfr. op. cit. pp. 43-44).
.
Il cinema cominciò nelle strade e nei vicoli, come un réportage di cronaca. Sfortunatamente, cadde nelle mani di gente di teatro, dal cui abbraccio il cinema si sta, per sua fortuna, lentamente liberando; per diventare arte autonoma, il cinema deve ritornare alla strada e al vicolo, alla cronaca. […] La rappresentazione teatrale è un quadro visto a distanza. Perché l’effetto globale sia simile alla realtà, il quadro deve essere dipinto a grosse pennellate, il colore deve essere dato a grossi colpi di spatola. Tutti i particolari devono essere resi in modo più crudo e ingranditi, devono essere esagerati. Nel teatro tutto è imitazione ed ogni cosa mira a portare i falsi dettagli in tale accordo tra loro e creare, assieme, una illusione colorata della realtà, mentre il cinema presenta la realtà stessa in una severa stilizzazione in bianco e nero.
La distanza fra teatro e cinema è data dalla distanza tra rappresentare ed essere. La sceneggiatura è di fondamentale importanza per un film. É certo che il cinema, se vuole rinnovarsi, deve rivolgersi agli scrittori, ma altrettanto certo è che una scena originale composta in forma di abbozzo, scritta per un film, ha minor valore di un romanzo o di un lavoro teatrale nel quale il soggetto è stato accuratamente elaborato e dove i pensieri hanno trovato la loro forma definitiva.
Poiché io definisco il vero film parlato come un film capace di avvincere soltanto per il suo contenuto psicologico, la sua trama e il suo dialogo, senza l’ausilio di effetti sonori esagerati, d’accompagnamento musicale o pezzi di musica inseriti, il lavoro teatrale psicologico deve essere certamente considerato come il materiale più adatto, a condizione che l’idea – madre del dramma, la sua materia prima – sia liberata dall’involucro della forma teatrale e divenga forma cinematografica. […]
Bisogna che il lavoro sia liberato da tutta la polvere accumulata tra le quinte del palcoscenico e della tradizione e, rispettando le intenzioni dell’autore, venga trasposto dal teatro alla vita reale.
.
«Nuove strade del cinema danese» (da Avertering del gennaio 1939, cfr. op. cit. pp. 63-64).
.
Possiamo senz’altro affermare che il film “disegnato”, mano a mano che la tecnica si perfeziona, si svilupperà nel film “dipinto”, che non confinerà se stesso al grottesco o ai racconti delle fate, ma si impegnerà in tutte quelle opere che, per il loro contenuto e la forma poetica o fantastica, non possono più d’ora in poi essere dominate dalla macchina da presa, poiché il troppo sobrio obiettivo fotografico non è in grado di riprodurre in maniera sufficiente il disegno o la pittura scaturiti dal pennello della immaginazione dell’artista. […] Il cartone animato si trasformerà dal presente stile manierato, passo a passo, in un’opera d’arte, nella quale la individualità dell’artista creatore potrà liberamente manifestarsi e il suo lavoro apparirà come un capolavoro organicamente creato dal suo spirito interiore.
.
«Tecnica e intuizione artistica», da Berlinske Tidende del 26 gennaio 1939 (op. cit. pp. 69-70).
.
La sceneggiatura vera e propria deve essere preparata dal regista – e da nessun altro. É decisamente un lavoro del regista; e suo soltanto. […] è solo il regista che avrà la responsabilità della sceneggiatura. É lui l’intermediario fra la sceneggiatura e lo schermo. E’ lui che deve rendere visibili i pensieri dell’autore. […]
Lasciare che altri compilino la sceneggiatura, equivale, per il regista a dare un disegno ultimato ad un pittore chiedendogli di metterci su i colori. […] La sceneggiatura non è una questione “tecnica”, ma “artistica” al più alto grado. Attraverso la sceneggiatura il regista dimostra di essere o no un artista. […] Ciò che occorre è un’intuizione artistica, un sentimento immediato dell’equilibrio ritmico – visivo, al momento in cui la sceneggiatura è divisa in quadri: un qualcosa che uno ha in se stesso (se lo ha) e non una questione di “tecniche “ che si possono imparare.
.
«Cinema a colori e film “colorati”», da Politiken del 27 febbraio 1955 (op. cit. pag. 113).
.
Si può trovare la poesia in uno scorcio qualsiasi della vita di ogni giorno, ma il film a colori non può imitare i colori della natura. La tendenza naturalistica ha rappresentato un serio impedimento ai film a colori. Abbiamo così spesso veduto l’erba verde e il cielo azzurro, da desiderare talvolta, una sola vota, di vedere il cielo verde e l’erba azzurra, perché avremmo scorto, forse dietro la rappresentazione pittorica, l’intenzione di un artista. […]
Accostarsi al film a colori con lo scopo di imitare la natura è errato. Non c’è nulla che possa impedire che i colori del film possano differire dalla natura e ugualmente – o persino conseguentemente – fornire allo spettatore una esperienza artistica più ricca.
Tra i miti che governano la vita dell’uomo occidentale, troneggia indisturbato quello della “giovinezza”, che tende a rattrappire l’intera esistenza degli uomini in quella fascia di età in cui si è esteticamente interessanti, economicamente produttivi, biologicamente forti. Così contratta, la maggior parte della vita: quella che precede la tracotanza giovanile, e ancor di più quella che la sopravanza, diventa inutile, ostaggio di quella triade (estetica, biologia, produttività) che ne desertifica il valore, la specificità, che ci trasforma in marionette.
.
Mikaël – Desiderio del cuore
.
Nel 1904 viene pubblicato in Danimarca un romanzo di Herman Bang intitolato Mikaël, nel quale, si narra di un “sentimento particolare “ tra un affermato pittore e un ragazzo che diventa ispirazione dei suoi quadri. Lo scrittore, a causa della propria omosessualità, è stato perennemente osteggiato dalla critica, sebbene i grandi intellettuali danesi dell’epoca, come Ibsen e Strindberg (il primo romanzo di Bang risale al 1880), ne abbiano colto da subito la novità letteraria.
Purtroppo, non sono molti i libri di Bang tradotti in italiano, sebbene, il romanzo in oggetto, sia tra questi. Per quanto concerne il cinema, Mikaël, ha avuto una duplice trasposizione su grande schermo: oltre a quella di Dreyer, datata 1924, troviamo un adattamento che risale al 1916, diretto da Mauritz Stiller, con il titolo Vingarne. La versione di Dreyer è stata girata in Germania in piena Repubblica di Weimar, condizione politica che ha reso possibile la diffusione della sottocultura omosessuale (grazie a personalità come Hirschfeld), e all’utilizzo della “settima arte” come ulteriore strumento di rappresentazione della realtà LGBT tedesca.
Da un punto di vista squisitamente tecnico, la pellicola del grande cineasta danese, si colloca in quel percorso che trova compimento con La passione di Giovanna d’Arco (1928), considerata dall’eminente critico francese André Lévison come l’ultimo dei film muti e il primo di quelli parlati. La cifra stilistica di Dreyer, caratterizzata da un’estetica del rigore, è già dispiegata in Mikaël, sebbene il lungometraggio, risenta degli stilemi classici del cinema espressionista.
Dreyer su Mikaël: Durante la lavorazione di questo film ho scoperto che esiste una differenza molto precisa fra un lavoro che viene costruito sotto il controllo dell’intelligenza e il lavoro “sentito”, nel quale l’attore è stato capace di eliminare tutti i sentimenti che non fossero esclusivamente quel complesso di sentimenti richiesti dall’opera.
E mi sono reso conto che il regista aveva davanti a sé un compito molto chiaro e importante, quello che consiste nel correggere l’attore dall’esterno e di guidarlo verso l’obiettivo che, nelle fotografie in primo piano, deve essere quello di dimenticare se stesso, di chiudersi all’intelletto e di aprirsi al cuore (Camillo Bassotto: Carl Theodor Dreyer: I miei film, Edizioni Cineforum, Venezia, 1965, pag. 170).
.
Trama
L’affermato pittore Claude Zoret, dopo aver bocciato alcune tele del giovane pittore Mikaël, chiede al ragazzo di restare nella sua casa e di diventare il suo modello di riferimento.
Accettata l’offerta, si crea tra maestro e discepolo un affetto particolare, che sfocia nell’adozione di Mikaël da parte di Zoret. Con la scusa di un ritratto, la principessa Zamikof, si insinua nella casa del maestro con lo scopo di poter essere sposata, e risolvere così la sua difficile situazione economica. Poiché i suoi tentativi falliscono, seduce Mikaël, che si trova così a dover scegliere tra l’amore di Zoret, e le continue richieste della Zamikof.
.
Scheda
.
Soggetto: dal romanzo Mikaël di Herman Bang.
Regia, sceneggiatura e montaggio: Carl Theodore Dreyer.
Fotografia: Karl Freund, Rudolf Maté
Scenografia: Hugo Hatting.
Produttore: Erich Pommer.
Casa di produzione: Decla Bioscop presso la Ufa di Berlino.
Interpreti e personaggi: Benjamin Christensen (nel ruolo del maestro Claude Zoret), Walter Zlezak (nel ruolo di Mikaël), Nora Gregor (nel ruolo della principessa Zamikof), Robert Garrison (nel ruolo del critico Switt), Didier Aslan (nel ruolo del duca di Montier), Grete Mosheim (nel ruolo della signora Adelsskjold).
Dato tecnico: film muto.
Genere: drammatico.
Anno: 1924 (prima assoluta: 26 settembre 1924 a Berlino; prima danese: 17 novembre 1924).
Durata: 90 minuti.
.
Per saperne di più
.
Bassotto C. (a cura di), Carl Theodor Dreyer: I miei film, Edizione Cineforum, Venezia, 1965.
Bernardi A. , Carl Theodor Dreyer, Le Mani, Genova, 2003.
Grmek Germani S. (a cura di), Dreyer. L’unica grande passione, Cinemazero, Pordenone, 2003.
Salvestroni S. , Il cinema di Dreyer e la spiritualità del Nord Europa, Marsilio, Venezia, 2011