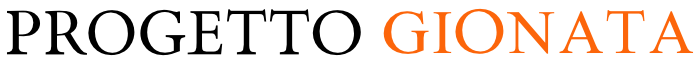Omosessualità e chiesa cattolica: su un rapporto controverso
 Articolo di Don Andrea Bigalli tratto dalla rivista Incontri, semestrale, n. 2, luglio-dicembre 2009
Articolo di Don Andrea Bigalli tratto dalla rivista Incontri, semestrale, n. 2, luglio-dicembre 2009
Vi sono elementi, nella dinamica delle complesse relazioni tra individui ed istituzioni, che hanno il potere di riassumere in sé prospettive ampie, di comprensione di un contesto.
Una delle grandi questioni della contemporaneità è giustappunto il rapporto tra le istanze presentate dalla persona (intesa non solo in senso emblematico ma anche come emergere delle esigenze e dell’importanza del singolo in quanto tale), e la struttura di cui essa fa parte, che per molti aspetti la definisce, regolamentando, favorendo o impedendo diversi aspetti della sua esistenza.
Alcune strutture della socialità assumono dimensione più rilevante di altre sul piano della produzione delle regole: la Chiesa Cattolica si prende carico di una complessiva difficoltà a definire le prospettive etiche e per questo sicuramente vive una serie di contrasti, che si focalizzano spesso sul rapporto tra diritti personali, legge, strutture del governo e del consenso sociale.
L’evoluzione dei costumi, con il sorgere di nuove opportunità, rese magari possibili dall’evoluzione tecnologica, comporta la necessità di definire liceità o inammissibilità (a volte addirittura proibizione) dei comportamenti e delle scelte. In una crescente fatica a definire i soggetti di questo processo – vista la perdurante crisi della realtà politica, che ne sarebbe la sede delegata – i conflitti tra esigenze e bisogni dei singoli e agenzie di senso etico diventeranno sempre più rilevanti.
Si pensi a quanto sta accadendo nell’ambito della bioetica, con un ruolo sempre più invasivo e devastante degli enti di informazione. Perché anche questo sta accadendo: il sistema mediatico ha un’importanza cresciuta fino alla totale pervasività, non c’è dibattito pubblico che da essa non sia registrato – e fin qui d’accordo, è suo compito – e soprattutto diretto e indirizzato, nella rinuncia pressoché generalizzata ad ogni istanza educativa.
Prima che tale dibattito arrivi nelle sedi deputate per la discussione pubblica (i sistemi giuridici, le aule parlamentari, i luoghi dell’elaborazione culturale), è vissuto in chiave definitoria presso trasmissioni televisive, prime pagine, salotti in cui si incontrano le persone che gestiscono, talora elaborano le notizie, non limitandosi a diffonderle e commentarle.
Sono in discussione i presupposti usuali della riflessione collettiva; questo fenomeno tende sempre più a banalizzare e involgarire i risultati di un processo che, dovendo arricchirsi a più livelli per la maggior complessità del reale, è al contrario sempre più soggetto alla banalizzazione.
Di tale dinamica soffrono particolarmente tutti gli attori sociali che propongono nel proprio agire una prospettiva etica: la chiesa cattolica è, tra questi, probabilmente la più discussa, e, nel contempo, l’ente che ha le maggiori difficoltà nel chiarire il proprio messaggio, l’intento complessivo della propria presenza sociale.
Forse perché le risultano sempre più difficili da comprendere, almeno fintanto che la maggior parte dei suoi membri si mantengono – come sovente accade – lontani dalle indicazioni del Vangelo, le sue autentiche istanze; non quelle che si presumono siano tali.
L’ignoranza della dottrina spesso produce una strumentalizzazione che riguarda sia le persone che sono di fronte al dettato etico della chiesa, che non possono rendersi conto se quanto viene detto loro è realmente indicazione di fede, sia buona parte del clero, che perdura spesso nel terrore che il popolo di Dio assuma posizioni critiche ben fondate se formato a dovere.
Grazie anche a questa ignoranza il rapporto tra cristiani e società laica resta difficoltoso, chiede continuamente la necessità di un rigore comunicativo e informativo. Difficoltà analoghe di comunicazione invece nascono proprio da differenze di impostazione etica, diverse chiavi di lettura dei fenomeni umani, dei comportamenti vissuti.
Da tempo la morale sessuale cattolica è intesa da buona parte della società – a torto o a ragione – come particolarmente inadatta a definire in tale campo le reali esigenze delle persone.
Nel contempo si può affermare senza particolari discussioni che essa è ancora in possesso di un sistema etico ben definito, uno dei pochi con cui ci si può confrontare a livello sociale ed individuale. Inevitabili quindi i motivi di frizione.
Quanto sto per scrivere non esula da questa considerazione: ma cercherà di porsi su di un altro piano, quello del come si debba tentare di costruire sistemi etici che mettono al loro centro anche le istanze delle minoranze, con un atteggiamento di ascolto e di accoglienza quale il Vangelo stesso richiede.
L’omosessualità è uno dei temi su cui molto si è discusso e che si presenta da tempo come uno degli argomenti può controversi. Da quando il movimento per la rivendicazione dei diritti per le persone omosessuali si è definito storicamente, introducendo anche istanze significative, indubbiamente legittime come la fine della discriminazione e della repressione violenta (si veda a proposito un bel film del regista statunitense Gus Van Sant del 2008, “Milk”, sull’attività e l’omicidio del primo politico americano eletto in quanto gay, Harvey Milk), la Chiesa si è trovata un interlocutore spesso polemico, peraltro non del tutto esterno al cattolicesimo, visto che i gruppi di omosessuali credenti sono molto più numerosi di quanto non si pensi.
Su di un livello immediato si può pensare che l’elemento più controverso da parte ecclesiale sia la valutazione dell’identità omosessuale, ma questa in realtà non è considerata negativa di per sé. Se si parte dalla considerazione che la condizione omosessuale non la si può scegliere e che la maggior pare delle persone che la vive niente ha potuto per non esserne parte, la condizione non è peccato di per sé.
Quel che la Chiesa contesta come immorali sono gli atti con cui si esprime l’amore omosessuale, ritenendo che essi siano contro natura, espressione di un disordine intrinseco.
Qui la dottrina chiede di essere esplicitata meglio, ma sembra che essa non possa fare a meno di definire l’omosessualità come una realtà comunque sbagliata – nonostante la premessa su una condizione di solito non liberamente scelta – dal momento che si considerano così negativi gli atti conseguenti, l’espressione fisica dell’identità.
A sostegno di questa interpretazione si può aggiungere che in tempi recenti si è definita la incompatibilità tra condizione omosessuale e ministero ordinato, impedendo ai gay di chiedere di essere ordinati presbiteri.
Si crea una contraddizione su cui occorrerà fare chiarezza: si rispettano le persone in quanto tali – il magistero condanna l’omofobia, non solo quella violenta: si parla dell’esigenza di non discriminare – ma nel contempo, condannando gli atti, si chiede alle persone omosessuali di non esprimere la loro dimensione affettiva, quindi in ultima analisi si vieta loro di vivere una parte consistente della propria identità.
Il problema resta quello di valutare che peso abbia la sessualità direttamente vissuta attraverso la genitalità nella vita delle persone, se sia giusto chiedere che non la si esprima anche a chi non abbia fatto scelte specifiche in tal senso. Su questo la sensibilità attuale si pone molto lontano dalla visione cattolica.
A tale quadro bisogna aggiungere quanto sia difficile affrontare la questione legata alla sessualità omosessuale nella chiesa cattolica (e non solo): permangono in molti i concetti di malattia, di anormalità, di una prospettiva intrinsecamente negativa coinvolgente vari aspetti della vita di queste persone, che continuano ad essere pensate in una diversità pericolosa o offensiva.
Continuano i pregiudizi sulle figure professionali, si pensa ancora che un maestro omosessuale sia pericoloso per i propri allievi, come se la tendenza fosse automaticamente corruttrice, capace di indurre a sua volta alla condizione.
Permane l’equazione omosessualità uguale pedofilia, che è particolarmente offensiva, tanto più quando si valuta che in realtà la maggioranza di chi soffre di questa patologia (questa è realmente una patologia, visto che coinvolge persone che non possono essere soggetti di una sessualità consapevole ed equilibrata) è eterosessuale.
Si vedano pure le polemiche riguardo al cambiamento dell’inclinazione sessuale, che secondo alcuni psicoterapeuti sarebbe possibile, consentendo la “guarigione” dell’omosessuale: su tale argomento le associazioni di gay annotano che si continua a pensare la condizione omosessuale nei parametri della patologia.
L’argomento è serio, non è proprio il caso di finire sui giornali perché si provano ad adoprare riti di esorcismo o terapie di accatto.
Inoltre non dimentichiamo che la problematica resta aperta in seno alla chiesa cattolica valutando anche il dato che una parte, minoritaria ma consistente, di clero vive questa identità: le testimonianze a riguardo si moltiplicano, indicando il disagio di chi sta vivendo una dimensione di totale rimozione della propria condizione all’interno di un ente che disapprova pubblicamente ciò che si vive in realtà parallele.
La problematica si focalizza infatti sulla perdurante chiusura che le gerarchie cattoliche oppongono alla necessità quantomeno di dialogare con associazioni e gruppi.
Mi capita spesso di sentir dire dai gay credenti quanto sembri assurdo al resto del mondo omosessuale il loro voler vivere la dimensione di fede nella chiesa cattolica, che li disprezza e reprime.
Tradotto, il dato indica che c’è un ambito pastorale che la chiesa ha per lo più abbandonato a sé stesso: è difficile portare l’annuncio evangelico quando si da ad intendere che esso contempli l’idea che una persona è sbagliata in sé, che il suo modo di intendere l’affettività la colloca totalmente al di fuori dell’amore divino, che la propria realtà escluda dalla comunione con i cosiddetti normali e via dicendo, secondo molte affermazioni che in realtà non fanno parte della dottrina cattolica ma che rischiano di apparire come tale, anche per la poca chiarezza con cui le realtà ecclesiali si pongono la questione e formano sulla tematica.
Quanto sono accoglienti, in questa come in altre dinamiche, le comunità parrocchiali? Non è che davvero – come accennavo all’inizio di questo articolo – stiamo parlando in realtà di una questione che può essere compresa come un paradigma di come la chiesa cattolica stia vivendo una difficoltà generalizzata ad affrontare le questioni in cui la problematica della differenza si presenta come destabilizzante, capace di introdurre domande complesse?
L’omosessualità di molti credenti è un dato pastorale incontrovertibile, ammesso che ci si debba interessare solo di quelli che sono cristiani: non penso che introdurre ad un dialogo con una minoranza sia necessariamente accettarne in toto filosofie ed istanze.
Del resto, il passaggio che decreta l’inaccettabilità degli atti omosessuali condanna i gay a non poter esprimere la loro affettività. Mi chiedo se non sia il caso quanto meno di porsi la questione, rileggendo il dato alla luce dell’etica dell’intenzione, che vede anche molti atti eterosessuali non legittimi in relazione all’intento negativo con cui li si vive.
Al contrario, un atto omosessuale che esprima un sentimento autentico di amore, perché deve essere necessariamente condannato?
A meno che non si continui a ritenere e ad affermare che quello omosessuale in realtà non può essere considerato amore. Ma un sentimento inteso in coscienza come tale, perché deve essere giudicato in maniera così negativa? Se constatiamo che esso produce nella vita delle persone un cambiamento positivo e significativo – come deve essere per l’amore – non si può valutare ciò come un segno di evoluzione che testimonia della qualità del sentimento stesso?
La vita delle coppie testimonia bellezza ed orrore, siano esse omo od etero sessuali: passa dalla libera volontà dei suoi componenti come si svolge il percorso di vita, secondo l’aspetto etico che si vuol esprimere.
Conosco coppie omosessuali che hanno dato prova di un sentimento forte e significativo, soprattutto in vicende negative di malattia, sofferenza, itinerario verso la morte di uno dei due o di congiunti.
Vale quanto meno la pena di ascoltare. In realtà ciò è proprio quanto chiedono i gay; essere ascoltati, accolti su di un piano umano, messi in condizione di esprimere la sofferenza del rifiuto e della discriminazione per poter pensare, in seno ad una chiesa a cui molti vogliono continuare ad appartenere, i termini di un percorso di fede e di spiritualità che non faccia mai sentire alcuno escluso dalla misericordia divina e dalla responsabilità di rispondervi con atti di carità e di giustizia.
È grave sentir raccontare di preti che neanche vogliono ascoltare, minacciando le fiamme dell’inferno, o di contesti ecclesiali in cui si respira un’atmosfera omofobica, di riduzione a categoria.
Il mondo omosessuale resta in attesa che si smetta di pensarlo separato dal resto dell’umano: affermo ciò anche come provocazione verso le associazioni e i gruppi di gay e lesbiche, invitandoli a non pensarsi parte di una prospettiva esclusiva, talora autoreferenziale.
Ma fintanto persiste marginalizzazione e pregiudizio restano i motivi perché questa prospettiva persista. Sopprimere i ghetti è la priorità. Chi ci contesta dal loro interno ha i suoi motivi, validi e no: ci fa comunque il servizio di provocarci alla franchezza e alla verità dei linguaggi con cui comunicare con chi, magari attaccandoci, forse ci chiede di essere quel che dobbiamo essere, secondo l’esigente prospettiva evangelica del servizio al mondo, soprattutto a partire da coloro che soffrono.
Quanto scritto tesse semplicemente ipotesi di azione pastorale, che vanno intese in un’ottica molto più vasta di una semplice istanza di rivendicazione.
La diversità è questione che introduce domande complesse alla contemporaneità, domande a cui il cristianesimo non è certo inadeguato o poco attrezzato: il nostro codice genetico è definito da un Vangelo che provoca con l’annuncio della pace fattibile l’impossibilità di dialogo che le culture teorizzano, dichiarano, mettono in atto.
Nell’ottica pastorale si tratta di chiedersi se sia il caso di mantenere un gruppo così ampio di persone (e secondo la carità pastorale anche soltanto un individuo pone la questione del doversi mettere in relazione con esso) al di fuori persino del dialogo, rimuovendo la questione che introducono con la loro stessa realtà umana.
Una chiesa che si arrende di fronte ad una problematica condannando delle persone a diventare esse stesse un problema, per il semplice fatto che esistono, non è degna del Vangelo.
Le realtà umane hanno sempre spinto la comunità cristiana a cercare nuovi linguaggi di comunicazione, nonostante i propri reciproci limiti; siamo sopravvissuti anche ai roghi degli eretici, pur restando questa, con altre, una fase storica che ci macchia fino alla fine dei tempi.
Non si può far finta che degli esseri umani non esistano. Non molto tempo fa il Vaticano ha dichiarato che non appoggerà la richiesta francese all’ONU di chiedere la decriminalizzazione mondiale dell’omosessualità, che in molti paesi (93) è ancora reato, in troppi passibile di condanna a morte.
Si adduce per tale scelta la motivazione del rischio che ciò consenta discriminazione nei confronti dei paesi che non contemplano nel loro patrimonio giuridico norme per la tutela di alcuni diritti civili dei gay, come riconoscimento dell’unione di fatto, matrimonio, adozione.
Non su tutto ciò occorre essere concordi, ma sulla necessità che in alcune aree del pianeta cessi la repressione, si. Ho ancora negli occhi l’immagine dei cinque uomini impiccati in piazza ad una gru a Teheran perché avevano amato altri uomini.
Si muore ancora perché si ama. Un crimine di tal fatta ci provoca al di là delle questioni di principio, che nessuno impedisce alla chiesa cattolica di affermare nelle sedi appropriate: la tutela della vita delle persone precede però ogni altra questione.
Credo che tutti abbiamo bisogno di intendere i cristiani come ben determinati ad affermare il valore della vita in ogni ambito e non soltanto in alcuni, la libertà di esistere come diritto inviolabile.
In attesa del tempo in cui gli esseri umani saranno semplicemente persone senza che ci sia bisogno di definirle secondo altre categorie, la fatica di questa stagione diventa sempre più evidente nella negazione del loro valore.
Compito anche nostro entrare in una dimensione culturale che metta i presupposti non solo per alleviarla, ma per consegnare i suoi motivi all’archivio delle realtà esaurite. Come è accaduto per tante altre realtà di discriminazione che tanto ci hanno fatto soffrire.