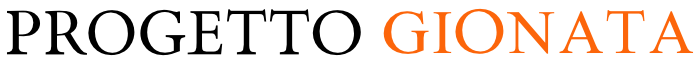Rimandati a Novembre. La CEI e il topolino sinodale
Riflessioni di Massimo Battaglio
E’ inutile che Mons. Castellucci, presidente del Comitato Nazionale del Cammino sinodale, ci giri tanto intorno. Le sue parole dette in ecclesiale stretto, in cui ostenta serenità dopo la bocciatura del documento finale del Sinodo italiano, lasciano trasparire sentimenti ben altri. Egli è perfettamente consapevole che le quaranta pagine di fuffa partorite dalla presidenza non erano altro che un ridicolo topolino. E se non lo fosse, se credesse davvero di aver fatto un bel lavoro, ci sarebbe seriamente da preoccuparsi.
Nel suo intervento finale in plenaria, rassicura che il suo stato d’animo “è di prevalente gratitudine a questa Assemblea, in tutte le sue componenti. E’ stata definita da alcuni un’Assemblea “ribelle”, ma è stata piuttosto un’Assemblea viva: critica, leale, appassionata per la Chiesa e la sua missione”.
Praticamente si dichiara favorevolmente stupito. Ma davvero credeva che questo manifesto di prudenza sfociante nella codardia potesse essere assunto dalla maggioranza dei membri dell’assemblea senza batter ciglio? E davvero è contento che l’assemblea stessa ne abbia disposto il ritiro e imposta una riformulazione più coraggiosa? Sembra di assistere pari pari ai primi passi del Concilio Vaticano II, quando la curia romana aveva già preconfezionato tutte le tesi illudendosi di ottenere un placet veloce e indolore, e invece fu sbugiardata dall’assemblea dei vescovi. Bene: è vero che da quel rifiuto cominciò un cammino di grande rinnovamento per la Chiesa. Ma il pro-prefetto del Sant’Uffizio cardinale Ottaviani, era tutt’altro che sereno, tutt’altro che contento.
Si dice giustamente che i punti che destano maggior discordia sono quelli sul ruolo delle donne e sull’omosessualità. E infatti essi non fanno che ripetere poche parole vaghe e insignificanti per dire che non se ne fa nulla, che è bene che tutto resti come prima. Ma lo fanno in modo gentile, con parole castigate, nell’illusione che nessuno se ne accorga. Non riesco a immaginare che Castellucci sia così ingenuo da non pensare che almeno questi punti sarebbero stati rigettati. Vediamoli.
La “Proposizione 2”, dunque uno dei primi punti della parte concreta del documento, è intitolata “Percorsi locali di formazione alla vita affettiva”. Lì dentro dovremmo esserci anche noi persone LGBT+. Si dice quanto segue:
“Le Diocesi, facendo perno sulla pastorale giovanile e familiare, propongano percorsi per la formazione alla corporeità-affettività-sessualità soprattutto di adolescenti e giovani e dei loro educatori, per il sostegno pastorale delle coppie e delle famiglie nei primi anni di vita insieme e per il sostegno alla genitorialità”.
Sbagliato: non ci siamo. Passiamo allora alla proposizione 5: “Accompagnamento delle persone in situazioni affettive particolari”. Questa volta dovremmo esserci, visto che si parla di situazioni “particolari” (queer, per dirla in americano). Recita così:
“Le Diocesi, avvalendosi anche di esperienze formative e prassi già in atto, si impegnino nella formazione di operatori e di nuovi percorsi perché le comunità siano compagne di viaggio e favoriscano l’integrazione delle persone che soffrono perché si sentono ai margini della vita ecclesiale a causa delle loro relazioni affettive o condizioni familiari “ferite” o non conformi al matrimonio sacramentale (sposati civilmente, divorziati in seconda unione, conviventi, etc.), del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere”.
Ecco il ridicolo topolino. Quanto era imbarazzato l’autore di questi arzigogoli mentre li stava scrivendo? E quanta malafede ci ha messo? Esaminiamo frase per frase.
Si riconosce che esistono “esperienze formative e prassi già in atto”. Tra esse, pare di poter riconoscere quella del “Tavolo Diocesano per la pastorale con le persone omosessuali” di Torino, o i gruppi che dialogano magari meno formalmente con le curie. Ma nel panorama ci sono anche robe come l’ “apostolato Courage” che vanno nella direzione opposta, predicando l’astinenza e vietando ai membri stessi di parlare di omosessualità. Quale strada vogliamo percorrere?
Si parla di persone che “si sentono ai margini della vita ecclesiale”. Eh no cari monsignori! Quel “si sentono” scarica la responsabilità della marginalizzazione addossandola tutta sui marginalizzati. Quasi che noi fossimo dei capricciosi che hanno l’impressione di non essere abbastanza valorizzati. Che molti di noi soffrano, è vero. Ma non soffriamo per la nostra condizione naturale ma per i trattamenti che subiamo e soprattutto per i riflessi che questo trattamenti finiscono per generare nella società e nelle decisioni politiche. E questa sofferenza non è soggettiva, non è una percezione, un “sentirsi”. E’ frutto di una discriminazione oggettivissima, della quale potremmo portare migliaia di esempi, esempi che parlano di persone che non “si stentono” emarginate (e insultate, e picchiate, e uccise) ma che “sono” tali.
Si mettono insieme tutte le situazioni “non conformi al matrimonio sacramentale”: gli “sposati civilmente”, i “divorziati in seconda unione”, i “conviventi” e, subito dopo, le persone omosessuali o bisessuali e transessuali. Vogliamo renderci conto che divorzio e omosessualità sono cose neanche parenti? La prima è una decisione umana; la seconda no. La prima è sempre un po’ un fallimento e non può che essere vissuta con dolore. La seconda no. In un mondo che non discriminasse, non ci sarebbero ragioni perché un gay fosse triste.
L’immagine stessa del gay sofferente ha qualcosa di ridicolo. Innanzitutto perché, come appena detto, un mondo in cui non soffrisse è possibile. E poi perché non abbiamo bisogno di compassione e di pietà. Non è della nostra eventuale tristezza, che la Chiesa si deve occupare, ma piuttosto del riconosciumento dei nostri diritti civili e morali: il diritto ad amarsi, il diritto di formare famiglie che non siano di serie B e, non ultimo, il diritto alla fede. In un’Italia in cui è ancora frequente sentire bestialità come quella per cui un gay non può essere cattolico, queste cose vanno dette, non sottaciute.
C’è la famosa parola “integrazione”. Cosa significa? Una trans può essere o non può essere catechista? Può fare o non può fare la Comunione? Dico meglio: un parroco può continuare a cacciare l’animatore gay quando scopre che ha un compagno? E può rifiutare di dargli i sacramenti? La risposta è elementare: no, non può. Non c’è nessun presupposto che giustifichi trattamenti di questo genere. Ma ditelo, per favore! Perché qua vige l’anarchia, insieme alla prepotenza e al frequente abuso del proprio ruolo.
“Integrazione” poi, non è una parola a due sensi. Non è come “comunione”, che presuppone un incontro in cui tutti gli invitati a tavola danno e ricevono qualcosa. “Integrazione” presume che qualcuno è ammesso a entrare nella casa di qualcun altro, dove, evidentemente, valgono le regole di quest’ultimo. E se la regola è: “noi ti accogliamo ma devi lasciare il tuo compagno” o anche “puoi continuare a fare la tua vita ma senza parlarne”, non va più bene.
La Chiesa deve capire, anche controvoglia se necessario, che le persone LGBT+ non hanno solo da ricevere ma anche molto da dare. Ciascuno di noi, a quella tavola, arriva con la sua torta salata o col suo “vino nuovo”: il vino nuovo della sensibilità che nasce dalla diversità, della forza che nasce dal superamento della discriminazione, dell’aver “lavato le proprie vesti rendendole candide nel sangue dell’Agnello” (Ap 7, 14). Esagero? No. Guardo semplicemente con obiettività le storie di tanti miei amici.
Perché la presidenza del Sinodo, che pure ha ascoltato testimonianze interessanti e ha preso parte a un dibattito piuttosto ricco, ha poi assunto una non-posizione così meschina esplicitandola in modo così ridicolo? Forse non sapevano a cosa appoggiarsi. Ma allora, che fine ha fatto “Fiducia Supplicans”? Ha subito mille commenti che tentavano di sminuirla e che ne hanno di fatto annullato l’effetto pratico ma non è mica stata ritirata. E i vari pronunciamenti ufficiali di papa Francesco in cui si riconosce che dalle unioni omosessuali può scaturire anche qualcosa di buono, non sono magistero?
Mi sa che il motivo del silenzio è un altro: da una parte c’è il desiderio di vendetta dell’ala “ruiniana” della CEI, con a capo l’assistente dell’Azione Cattolica mons. Claudio Giuliodori, già incattivita all’epoca dell’elezione di Bergoglio e ulteriormente inacidita con la nomina di Zuppi (roba che col Vangelo c’entra come un calcio sui maccheroni). Dall’altra, c’è la paura di Pro-Vita e di tutto l’arcipelago che le gira intorno. Paura fondata, visto il potere che ormai ha conquistato in Italia fino a esprimere ministri e presidenti della Camera. Ma allora, che significato ha aprire la prima parte propositiva del testo facendo appello alla “portata critica e profetica della fede”? Facciamo i critici e i profeti finché è facile ma poi cediamo ai poteri forti?
Sarebbe interessante ricordare che né Pro-Vita né alcun’altro gruppo di paladini contro il “gender” gode di alcun riconoscimento ecclesiale. Si tratta di semplici associazioni culturali o di promozione sociale, che non prevedono nessun cammino di formazione spirituale e nessuna prassi di fede. Non hanno accompagnatori religiosi, né laici né tantomeno ordinati. La Chiesa dovrebbe rapportarsi a loro esattamente come alla Bocciofila Pensionati e Amici o al Gruppo per la Protezione del Gatto. Al contrario, con le “esperienze formative e prassi già in atto” sopra citate, deve rapportarsi eccome, imparando il tanto che c’è da imparare e non limitandosi a un anonimo riconoscimento formale.
Ci vedo tanta “Tele-Meloni”, in questa “proposizione numero 5”: tanto chinare la testa al dettato del più forte. E’ quasi un Magnificat al contrario, in cui sia scritto: “si è abbassato ai voleri dei superbi, ha confermato i potenti sui loro troni e umiliato gli umili”. Altro che profezia!