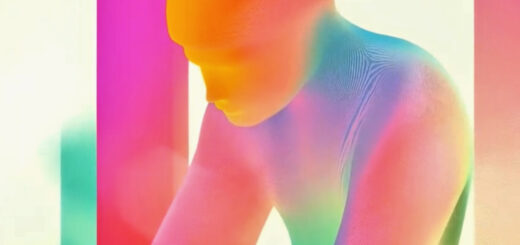“Saving Face” e la fioritura del New Queer Cinema lesbico
Scheda di Luciano Ragusa con cui è stato presentato al Guado il film “Saving face” di Alice Wu il 15 maggio 2022
Vale la pena, ancora una volta, sottolineare come il cinema indipendente offra sottospazi che, le “major”, non concedono per ragioni economiche e distributive. Per correttezza informativa è giusto evidenziare che non tutti i cineasti, soprattutto quelli che appartengono a minoranze etniche e di genere, hanno trovato accesso, all’interno del settore “indie”, ai finanziamenti.
È comodo dimostrare che la facilità con cui viene rifiutato un progetto di un regista di colore è superiore ad uno di pelle chiara; stessa cosa per la controparte femminile, e ancor di più se, al “gentil sesso”, aggiungiamo il colore nero. Le donne registe nere rimangono in secondo piano, e devono faticare esponenzialmente di più, rispetto ai colleghi maschi e alle colleghe bianche, per produrre e distribuire le proprie opere, danneggiate oltremisura dalla doppia disuguaglianza.
Per fortuna, sebbene le discriminazioni seguano lo stesso schema, il settore indipendente ha dato ampio spazio alle minoranze relative all’orientamento sessuale: infatti, uno dei fenomeni che ha contribuito all’espansione del cinema indipendente all’inizio degli anni 90’, è noto come New Queer Cinema, il nuovo cinema omosessuale.
L’espressione compare per la prima volta, all’interno di un articolo, nel 1992 grazie a B. Ruby Rich, professoressa emerita di film e media digitali e documentazione sociale presso l’UC Santa Cruz. Critica di pellicole indipendenti, femministe e queer, B. Ruby Rich si accorge che la proposta a basso costo, costruita con un linguaggio formale innovativo, relativa ad argomenti lgbtq+, evidenzia un tacito accordo tra un gruppo nutrito di autori giovani, e un pubblico gay e lesbico fortemente interessato al contenuto.
Fa notare Geoff King, nel suo libro dedicato al cinema indipendente americano (G. King, Il cinema indipendente americano, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, tr.it. 2006), che il New Queer Cinema è un prodotto del suo tempo: in primis per lo sviluppo dell’area “indie” in quanto tale; e poi per le alleanze – a causa per esempio dell’epidemia di AIDS, o di una stampa di genere finalmente pronta, dopo decenni di rispettabilità, all’ostentazione di una sessualità trasgressiva – che finalmente le realtà omosessuali avevano generato.
Il momento era propizio per il fiorire di una narrazione lgbtq+ distante dai luoghi comuni su cui il cinema mainstream si è sempre adagiato. Il punto di vista, grazie a registi come G. Van Sant, G. Araki, B. La Bruce, T. Haynes, T. Kalin, ecc., esplode in sottogeneri, i quali, per mezzo dell’innovazione formale che ne accompagna spesso lo sviluppo, e la varietà dei soggetti a cui attingere, nella migliore delle ipotesi diventano pellicole di culto.
Certamente, negli anni 60’, una parte del cinema d’avanguardia si era occupato di omosessualità: artisti e registi come Kenneth Anger, Jack Smith, Andy Warhol, sono artefici di medio e lungometraggi dove i rapporti tra uomini sono il centro della storia, ma, l’esperienza, è prevalentemente estetica, manca cioè della pregiudiziale ideologico-rivendicativa con cui, dopo la nascita del movimento gay lesbico, chiunque parlasse di rapporti omoaffettivi, doveva fare i conti.
Dunque, a metà degli anni 80’ (cfr. scheda di Mala noche, 1985), come i prodotti di altri gruppi marginalizzati, i punti di vista di gay e lesbiche sono stati confinati nel settore indipendente per necessità, perché non potevano essere realizzati in altri luoghi. Alcuni anni dopo, tra il 1989 e il 1995, la risposta di un pubblico compatto, maturo, ne spinge la produzione orientandone, dove possibile, la qualità.
LE REGISTE DEL NEW QUEER CINEMA
Sono ancora molte le strategie da adottare affinché la parità, tra uomini e donne, sia effettivamente raggiunta. Se ci concentriamo, per esempio, ai territori che competono l’industria cinematografica, le maestranze, in tutte le fasi di lavorazione, sono nettamente a maggioranza maschile.
Uno studio condotto nel 2016 dalla dottoressa Martha Lauzen, direttore esecutivo del Center for the Study of Women in Television and Film dell’Università di San Diego, ha dimostrato che le opportunità per le donne che lavorano nei ruoli creativi al vertice dell’industria cinematografica, sono diminuite, di due punti percentuali, rispetto al 1998, anno della prima rilevazione.
La dottoressa Lauzen palesa che solo il 17% del totale è di sesso femminile: percentuale che, nel 2020, dopo quattro anni di campagne di sensibilizzazione, raggiunge il 30%. Le cifre si spostano leggermente verso l’alto qualora considerassimo le produzioni indipendenti, ma sempre distanti da quote egualitarie.
Doverosa, pertanto, una pagina dedicata al New Queer Cinema nella sua componente femminile, sebbene, un altissimo numero di pellicole girate dalle autrici, siano introvabili.
Precursore di un punto di vista lesbico nel cinema è Dorothy Arzner: nata nel 1897, approda a Hollywood dopo la Prima guerra mondiale come stenografa. Negli anni 20’ impara la tecnica del montaggio e comincia a scrivere sceneggiature, fino a quando, compie il salto dietro la macchina da presa. Muore nel 1979, dopo averci lasciato Working Girls (1931), Craig’s Wife (1936), Dance Girl Dance (1940), film dove primeggiano figure femminili non disposte a mediazioni al ribasso.
Autrice di Women I Love (1976), dove si celebra il corpo femminile e l’indipendenza di un amore saffico, è Barbara Hammer, straordinaria pioniera del cinema queer “tout court” e accademica all’ European Graduate School. Scompare nel 2019 all’età di ottant’anni.
Anche se canadese, classe 1945, non posso eludere Donna Deitch, regista di uno dei film indipendenti di maggior successo del decennio 80’: ispirato al romanzo di Jane Rule, Desert of the Heart (1985), narra di una storia d’amore tra donne ai confini del deserto del Nevada, nella quale, finalmente, trionfa il lieto fine (primo film dove la coppia lesbica è un’opzione primaria).
Fondamentale è Cheryl Dunye (classe 1966), la prima regista lgbtq+ di colore: il suo più celebre lungometraggio, The Watermelon Woman (1996), racconta la figura di Fae Richards, attrice lesbica afroamericana degli anni 30’, che diventa metafora delle difficoltà che le donne nere di origine africana continuano ad avere sul finire del millennio.
Tra i nuovi talenti statunitensi del cinema queer, c’è sicuramente Dee Rees, nata a Nashville da genitori liberiani nel 1977. Nel suo cinema si intersecano temi come l’orientamento sessuale e la razza: il suo primo lungometraggio è datato 2011, Pariah, nel quale Spike Lee compare tra i produttori esecutivi. Segue Bessie (2015), biopic anni 30’ sulla cantante bisessuale Bessie Smith; Mudbound (2017, candidato a quattro Oscar 2018 compresa Miglior sceneggiatura non originale alla filmmaker), tratta del rapporto tra due famiglie, una bianca e una nera, durante la Seconda guerra mondiale. La regista vive ad Harlem con la moglie Sarah M. Broom, scrittrice e poetessa.
Segnalo, infine, Isabelle Sandoval, attrice e regista filippina con uno strettissimo legame con il cinema indipendente americano. Nata nel 1982 è la prima donna trans di colore a competere, nel 2019, alla Mostra del cinema di Venezia, con il film Lingua Franca: Olivia, immigrata filippina con il permesso di soggiorno scaduto nell’America trumpiana, cerca soluzioni per restare negli USA. La difficoltà è acuita dal suo orientamento sessuale transgender.
Ricordo, come sempre succede nelle schede in cui sono elencati lungometraggi e filmmakers, che sono tutt’altro che esaustive: al lettore, il compito di aggiungere personaggi e pellicole.
SAVING FACE – SALVARE LA FACCIA
Nata a San Jose, California, nel 1970 da genitori taiwanesi, Alice Wu si è laureata in informatica all’Università di Stanford. Non poteva essere altrimenti, perché San Jose, è situata nella regione oggi nota come Silicon Valley, luogo deputato alla ricerca e sperimentazione di linguaggi informatici all’avanguardia.
Accanto alla passione per l’ingegneria informatica sviluppa il suo interesse per il cinema, tant’è che sul finire degli anni 90’, la troviamo all’Università di Washington a studiare sceneggiatura, dopodiché a New York a perfezionare la sua carriera cinematografica.
Debutta nel 2004 con Salvare la faccia (tra i produttori compare Will Smith), lungometraggio che partecipa, l’anno successivo, al Toronto International Film Festival, al Sundance Film Festival e al Seattle International Film Festival.
L’opera della Wu dimostra come ciascuno, indipendentemente dalle origini di cui è portatore, debba lottare contro i pregiudizi veicolati dal concetto di rispettabilità. Nel contesto del film è chiamata in causa la comunità cino-americana, alla quale la regista sente di appartenere, con le sue tradizioni e il tentativo di conservarle.
Per molti anni, Alice Wu, sparisce dai radar cinematografici, fino a quando, nel 2020, la piattaforma Netflix distribuisce (anche in italiano) L’altra metà, commedia drammatico-sentimentale liberamente ispirata al Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, che ha ricevuto un buon riscontro di pubblico.
SCHEDA DEL FILM:
Soggetto, regia e sceneggiatura: Alice Wu.
Fotografia: Harlan Bosmajian.
Musica: Anton Sanko.
Montaggio: Susan Graef, Sabine Hoffman.
Produttore: Will Smith, James Lassiter, Teddy Zee.
Distribuzione in italiano: Sony Pictures Home Entertainment, 2006.
Cast: Michelle Krusiec (Wilhelmina Pang); Joan Chen (Hwei-lang Gao); Lynn Chen (Vivian Shing); Jessica Hecht (Randy); Ato Hessandoh (Jay); Wang Luoyong (signor Shing); Qian Luo (signora Shing); David Shih (Norman).
Genere: commedia; anno: 2004; durata: 95’.
TRAMA
Wilhelmina, detta “Wil”, viene costretta dalla madre a partecipare ad un raduno organizzato dalla comunità cino-americana, con l’intento dichiarato di farla accasare con un uomo. Durante la festa incontra Vivian, di origine cinese, della quale Wil si innamora istantaneamente. Vivian ricambia l’affetto ma, le pressioni della comunità, ed una rispettabilità anteposta a qualsiasi sogno, mette a dura prova la genuinità del loro sentimento.