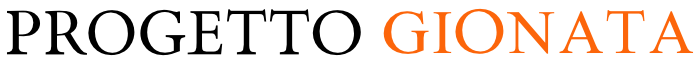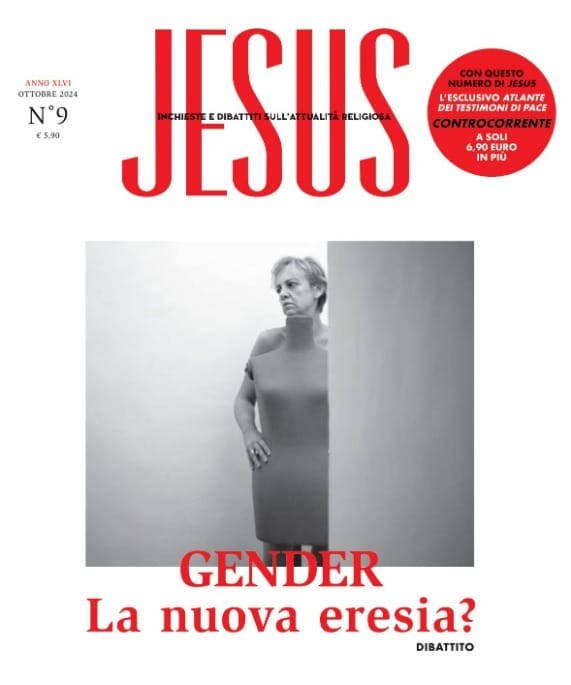Sul mensile Jesus di ottobre 2024 si discute di “Gender. La nuova eresia?”
Articolo di Luca Kocci pubblicato su Adista Notizie n° 37 del 26 ottobre 2024, pp.8-9
Il gender è la nuova eresia? La provocatoria domanda mette bene a fuoco il tema sviscerato da Jesus, mensile dei religiosi paolini molto diffuso nelle parrocchie, nel corposo approfondimento pubblicato nel fascicolo della rivista di ottobre.
«Come ha osservato il teologo don Aristide Fumagalli, la parola gender è “un attaccapanni a cui vengono appesi e sovrapposti modi diversi d’intenderlo”», scrivono nell’introduzione i due curatori, Giovanni Ferrò e Paolo Rappellino. «Da una parte c’è chi con gender intende i gender studies, gli studi interdisciplinari (teologia compresa) che si occupano di come la cultura interpreta e condiziona i ruoli e le conseguenti discriminazioni legate all’essere uomini o donne; dall’altra c’è chi invece con gender intende un’ideologia che vorrebbe cancellare il dato biologico, che incoraggia il cambio di sesso degli adolescenti e che bramerebbe un’umanità dall’identità indistinta. E poi, nel parlare comune, gender è persino diventato, in modo del tutto improprio, sinonimo di omosessualità e transessualità. Di fronte a questa babele, nel dibattito dell’opinione pubblica complessiva così come nella Chiesa, le incomprensioni regnano sovrane ed è sempre più difficile capirsi».
È allora assai utile a fare chiarezza il dibattito sollecitato da Jesus fra Antonio Autiero (professore emerito di Teologia morale all’Università di Münster), Lucia Vantini (docente di Teologia fondamentale e di Antropologia filosofica allo Studio teologico San Zeno e all’Issr di Verona), don Angelo Biscardi (docente di Antropologia teologica all’Issr della Toscana) e Sandra Letizia (insegnante di Religione cattolica a Palermo).
Maschera del patriarcato
L’ideologia gender è «l’ideologia di coloro che hanno costruito un fantasma attorno alla parola gender, non vogliono mettersi in ascolto degli studi di genere e hanno ostacolato questi studi proprio con parole che non corrispondono neanche epistemologicamente a quello che si sta facendo sul piano dello studio», spiega Vantini, che poi sintetizza: «È l’ideologia del patriarcato, che si è mascherato in tanti modi».
Se, come argomenta Biscardi, «il sesso è la determinazione biologica dell’essere maschio o femmina» mentre il genere «rappresenta tutto ciò che possiamo agganciare all’essere maschi o all’essere femmina (gli elementi simbolici, le predisposizioni caratteriali, psichiche, l’inclinazione culturale ad assumere determinati ruoli…)», allora «gli studi di genere valutano come la cultura cambia queste associazioni». Invece negli ultimi anni la parola gender è stata stravolta e trasformata in «un marcatore identitario dell’essere cattolico», al punto che in molti ambienti si chiede: «Ma tu sei a favore o contro il gender?». E «in base alla risposta si viene considerati ortodossi (cioè veri rappresentanti della Chiesa) o meno».
Aggiunge Letizia: «Anche il fatto di utilizzare in maniera indistinta “teoria” e “ideologia” fa capire che chi ne parla lo fa senza cognizione di causa. Si tratta di persone che semplicemente non sanno di cosa stanno discutendo». Mentre questi studi, prosegue, «servono a riflettere sui danni che gli stereotipi di genere hanno portato e continuano a portare e mirano a trovare delle soluzioni contro le discriminazioni. Quindi possono avere delle importanti ricadute a livello sociale e politico per la costruzione di una società che sia più giusta per tutti, dove tutti hanno le stesse opportunità indipendentemente dal genere», «non hanno in sé niente di ideologico. Ci fanno vedere che l’essere umano e la società sono molto più complessi della divisione binaria uomodonna. E che c’è un’evoluzione nel tempo».
Sex e gender
Il magistero ha affrontato il tema in particolare nella Dignitas infinita, pubblicato a marzo 2024 dal Dicastero per la dottrina della fede, dove si parla, fra l’altro di «distinguere ma non separare» sesso biologico (sex) e ruolo sociale-culturale del sesso (gender). «Il problema sorge quando chi valuta la distinzione, invocando tutta la continuità possibile, lo fa dando alla sfera biologica una sorta di valore normativo e attribuisce alla sfera sociale prevalentemente un senso negativo, come di qualcosa che vuole disattendere, eliminare, sottovalutare la sfera biologico-naturale – puntualizza Autiero –. In questo modo non si tiene in debito conto l’importanza delle componenti culturali e delle dinamiche sociali, come anche delle aspirazioni personali e dei desideri legittimi che concorrono alla costruzione dell’identità personale. Insomma, avverto un certo disagio quando fiuto che chi, a pur giusta ragione, tende a custodire questa regola del “distinguere ma non separare”, in realtà marca prevalentemente il criterio normativo della sfera biologica su quella antropologica. Gli studi di genere ci rendono attenti a non cadere in questa strettoia».
Aggiunge Letizia: «Se “distinguere e non separare” lo dobbiamo intendere in maniera rigida e binaria, delineiamo un’esistenza umana in cui potrei essere costretta a essere ciò che non sono, perché devo seguire questo dettame di inseparabilità tra sesso e genere. Invece, sostenere che c’è una differenza tra sesso e genere, che sono inseparabili ma non devono essere collegati in maniera binaria e rigida, vuol dire esaltare l’immensa ricchezza che c’è nell’essere umano. Dio ci ha donato questa libertà di costruire la nostra identità anche sulla base delle relazioni che intrecciamo, delle esperienze che facciamo.
L’amore è un’alleanza tra due differenze, ma che queste due differenze debbano essere determinate solo dalla differenza biologica a me pare molto riduttivo. Due persone sono diverse in molto altro, oltre che i genitali. La capacità generativa dell’essere umano non si ferma al mettere al mondo figli, è molto altro: è il dialogo, è l’inventare, il costruire, è l’arte, è il prendersi cura dell’altro, è il crescere insieme».
Il papa in altalena
E papa Francesco come si pone di fronte al tema? In maniera decisamente altalenante, distinguendo sempre tra livello pastorale e livello dottrinale. «Ma se si accentua ancora la distinzione tra “pastorale” e “dottrinale”, allora abbiamo un problema di recezione del Vaticano II – rileva Autiero –. Vuol dire che siamo bloccati sia nella concezione che nell’elaborazione della dottrina che nella consapevolezza dell’importanza della prassi. Alla base c’è l’idea della dottrina come di un apparato di principi irriformabili e dell’approccio pastorale come di qualcosa puramente applicativo, adattativo di tali principi alle diverse circostanze».
Lo «sganciamento della teologia dalla pastorale è fortemente dannoso – prosegue Biscardi –. Penso ci sia anche un problema di come si pensa il magistero: ancora a servizio di una serie di pronunciamenti dottrinali, dedotti dall’impianto metafisico tradizionale. Un magistero che non viene “bagnato” dalla prospettiva pastorale, che poi in realtà è la prospettiva dell’incarnazione, insomma, della realtà. Probabilmente papa Francesco pensa che sia necessario abituare i credenti a un dibattito e intende far maturare un consenso su alcune questioni che invece in questo momento sarebbero estremamente divisive».
È vero, conclude Autiero, che però segnala il pericolo di immobilismo: «il rischio di non fare progressi su determinate tematiche è connesso con il regresso e con lo svuotamento dall’interno dell’autenticità del messaggio stesso». Insomma la strada pare ancora lunga, e in salita.